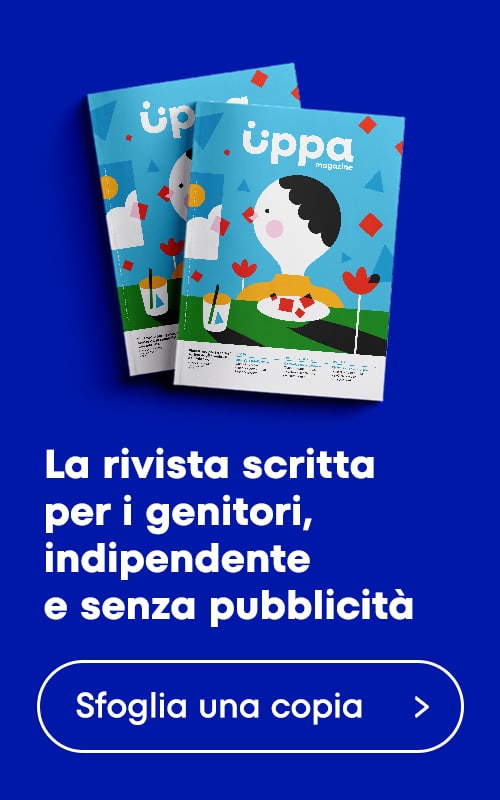Vaccino per il papillomavirus: perché è importante proteggere soprattutto i giovani
Si stima che l’80% delle persone sessualmente attive entrino in contatto con il virus nel corso della loro vita. Ecco perché, pur non rientrando tra i vaccini obbligatori, la sua somministrazione è fortemente raccomandata nel dodicesimo anno di età, quando la sua efficacia è più elevata

Spesso si pensa che le vaccinazioni siano riservate ai bambini piccoli oppure alle persone anziane (come nel caso dell’antinfluenzale oppure per quella contro Covid-19), ma ci sono vaccini che sono raccomandati anche per gli adolescenti e per le persone adulte. Tra questi c’è il vaccino per il papillomavirus (HPV, human papillomavirus), virus molto diffuso (è la più comune infezione sessualmente trasmessa nei Paesi ad alto reddito) la cui infezione può far sorgere malattie cutanee e delle mucose; ad oggi, è l’unica infezione riconosciuta come causa necessaria per l’insorgenza del tumore della cervice uterina.
In questo articolo cercheremo di capire come funziona il vaccino per il papillomavirus e perché è importante promuoverne la somministrazione.
Cos’è il papillomavirus
Cos’è il papillomavirus e come funziona esattamente? L’HPV è un virus trasmesso prevalentemente per via sessuale che infetta le cellule della cute e delle mucose, dando origine a lesioni (verruche, condilomi) e in alcuni casi a tumori (collo dell’utero, ano, genitali esterni, cavo orale).
Come si trasmette il papillomavirus? Si tratta dell’infezione a trasmissione sessuale più frequente: si stima che l’80% delle persone sessualmente attive entrino in contatto con questo virus nel corso della loro vita.
Al contrario di altre infezioni a trasmissione sessuale, l’uso del profilattico riduce il rischio di contagio ma non lo evita completamente, perché la trasmissione può avvenire anche attraverso il contatto pelle a pelle con aree non protette dal preservativo.
Nella maggior parte dei casi l’infezione da HPV avviene senza sintomi o, meno frequentemente, con la comparsa di verruche o condilomi e nell’arco di uno-due anni il virus viene eliminato grazie alla risposta immunitaria. In alcuni casi, però, il virus può rimanere più a lungo nell’organismo e causare lesioni che con il tempo (molti anni) possono progredire verso lo sviluppo di un tumore. Ci sono diversi fattori che possono influenzare la possibilità che il virus rimanga nell’organismo per molto tempo:
- il tipo di HPV;
- la risposta immunitaria;
- fattori genetici;
- fattori ambientali (ad esempio il fumo di sigaretta).
Esistono più di 200 tipi di papillomavirus e di questi quelli associati allo sviluppo di un tumore sono 14, definiti anche “ad alto rischio oncogeno”. I tipi 16 e 18 sono quelli più frequentemente responsabili del tumore del collo dell’utero (da soli sono associati a 7 casi su 10). Ci sono poi tipi di HPV raramente associati ai tumori (basso rischio oncogeno) e tra questi i tipi 6 e 11 sono quelli maggiormente associati ai condilomi.
Nel caso del tumore alla cervice uterina, l’HPV rappresenta l’unica causa: proteggere dall’infezione virale significa evitare lo sviluppo del tumore. Per altri tumori, invece, il virus è una delle cause ma non l’unica, con una percentuale che varia dal 40% per i tumori della vulva a circa il 90% nel caso di tumori dell’ano.
Vaccino per l’HPV: cos’è e da cosa protegge
Come funziona il vaccino per il papillomavirus? Qual è l’efficacia del vaccino per il tumore al collo dell’utero?
Il vaccino nonavalente contro il papillomavirus protegge da 9 tipi di HPV, tra cui i tipi 6,11,16 e 18. Contiene alcune proteine del virus insieme a sali di alluminio utilizzati per stimolare la risposta del sistema immunitario (effetto adiuvante).
Il vaccino ha un’elevata efficacia nel prevenire le infezioni da HPV e nel ridurre l’incidenza di lesioni precancerose. Dal momento che il tumore si sviluppa dopo molti anni dall’infezione, i dati sulla riduzione dei casi di cancro del collo dell’utero sono ancora limitati, ma è alquanto probabile che si possano applicare le stime riguardanti le lesioni precancerose. Nelle ragazze che si sono vaccinate prima dei 14 anni di età, l’efficacia nel prevenire le infezioni e le lesioni precancerose da virus contenuti nel vaccino (in particolare i tipi 16 e 18) è superiore al 90%.
Gli studi disponibili indicano che il beneficio della vaccinazione si estende anche alla popolazione non vaccinata: grazie alla diminuzione della circolazione del virus, nei contesti con un’elevata percentuale di ragazze vaccinate si è osservata una minore incidenza di lesioni anche nelle donne adulte, non coinvolte nella campagna vaccinale.
Grazie al vaccino è alquanto probabile che nell’arco dei prossimi 10 anni in Australia il tumore alla cervice uterina diventi un evento estremamente raro e altre nazioni, come ad esempio la Norvegia, il Canada e il Regno Unito, potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo.
Vaccino per il papillomavirus: quando farlo
Il vaccino per il papillomavirus a che età va fatto? È raccomandato per le ragazze e i ragazzi nel corso del dodicesimo anno di vita (tra gli 11 anni compiuti e il compimento dei 12) e prevede la somministrazione per via intramuscolare di due dosi, la seconda a distanza di 6-12 mesi dalla prima.
La vaccinazione è raccomandata in questa fascia di età perché la sua efficacia è più elevata se somministrata prima dell’inizio dell’attività sessuale, ma può essere effettuata anche dalle ragazze e dai ragazzi più grandi e dagli adulti. Dopo i 14 anni di età sono previste tre dosi (la seconda a distanza di 2 mesi dalla prima e la terza a distanza di sei mesi dalla prima).
Vaccino HPV per donna e uomo: proteggere entrambi è essenziale
Abbiamo compreso quanto il vaccino HPV per la donna rappresenti una forma di prevenzione molto importante. E per l’uomo?
Al momento della sua introduzione in Italia (2007), la vaccinazione contro l’HPV era raccomandata e offerta gratuitamente alle ragazze, ma a partire dal 2017 la raccomandazione e l’offerta del vaccino è stata estesa in tutto il territorio nazionale anche ai ragazzi, adottando la strategia gender neutral raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da altre istituzioni sanitarie internazionali.
Sono differenti le ragioni che motivano l’importanza di offrire il vaccino del papillomavirus ai maschi. Dal punto di vista della protezione individuale, i condilomi e i tumori associati all’HPV non colpiscono solo le donne. L’obiettivo principale della prevenzione vaccinale è la riduzione dell’incidenza del tumore della cervice uterina, che è sempre associato all’infezione da papillomavirus, ma occorre considerare che la vaccinazione riduce anche il rischio di altri tumori, con un’incidenza inferiore e non in tutti i casi dovuti all’HPV. Nel dettaglio, parliamo dei tumori che interessano:
- ano;
- pene;
- vagina;
- vulva;
- cavo orale.
Il vaccino contro il papillomavirus maschile è inoltre importante nell’ottica della salute collettiva: per ridurre la circolazione del virus e cercare di raggiungere l’immunità di gruppo è essenziale che siano vaccinati sia i ragazzi che le ragazze. Infine, la strategia vaccinale neutra garantisce l’equità nell’accesso a questo intervento preventivo.
Vaccino HPV e adulti
Come detto, l’efficacia del vaccino contro il papillomavirus è massima nelle persone che non sono mai entrate in contatto con il virus, ed è per questo motivo che la vaccinazione è raccomandata e offerta in via prioritaria alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età. Ma è in ogni caso raccomandata una vaccinazione cosiddetta “di recupero” per le ragazze non vaccinate (o che non hanno completato il ciclo vaccinale) fino ai 26 anni di età e per i ragazzi fino ai 18 anni.
Quanto è raccomandabile ed efficace, invece, il vaccino HPV per gli adulti?
Dopo i 26 anni di età la diminuita efficacia del vaccino non rende più sostenibile l’offerta di questo intervento preventivo a tutta la popolazione. Negli adulti l’utilità della vaccinazione può tuttavia dipendere dallo stato di salute individuale e dalle abitudini sessuali e può essere valutata con il medico curante o con uno specialista (andrologo/a o urologo/a per gli uomini; ginecologo/a per le donne). Ad esempio, nelle donne con un intervento di asportazione di una porzione del collo dell’utero (conizzazione) in seguito alla presenza di una lesione precancerosa, la vaccinazione potrebbe ridurre il rischio di reinfezioni e di recidive. In generale, alcuni studi indicano che nelle persone con infezione da HPV il vaccino potrebbe stimolare la risposta immunitaria e favorire l’eliminazione del virus (ma le prove scientifiche al riguardo non sono conclusive).
Un’altra condizione di salute in cui la vaccinazione è consigliabile è l’assunzione di farmaci immunosoppressori o la presenza di malattie che riducono la risposta immunitaria.
Vaccino HPV e gravidanza
Non contenendo un virus vivo attenuato, il vaccino HPV non è in grado di causare un’infezione. Non è, quindi, necessario lasciar trascorrere un intervallo di tempo tra il termine del ciclo vaccinale e la ricerca di una gravidanza, come raccomandato per altri vaccini come l’antirosolia e l’antivaricella.
I dati disponibili riguardanti donne che sono state vaccinate durante le prime settimane di gravidanza (prima che la gestazione fosse accertata) non indicano, in ogni caso, un aumento del rischio di malformazioni e sono, quindi, ulteriormente tranquillizzanti.
Vaccino per il papillomavirus: gli effetti collaterali
Gli effetti collaterali del vaccino per il papillomavirus sono generalmente lievi. Quelli più frequenti sono:
- gonfiore e dolore nel sito dell’iniezione;
- febbre;
- dolori muscolari e articolari;
- disturbi gastrointestinali.
Gli studi disponibili non hanno invece osservato un’associazione tra il vaccino HPV e l’insorgenza di malattie autoimmuni o di sclerosi multipla.
Vaccino per il papillomavirus: pro e contro
Le uniche controindicazioni al vaccino HPV riguardano l’ipersensibilità nei confronti dei componenti del vaccino o l’insorgenza di reazioni allergiche gravi dopo precedenti somministrazioni.
Dunque: vaccino per il papillomavirus sì o no? Questa vaccinazione non rientra tra quelle obbligatorie, ma ciò non significa che sia meno importante. Come abbiamo visto, il beneficio del vaccino cambia con l’età e le condizioni individuali: è massimo nelle ragazze e nei ragazzi dodicenni e rimane rilevante se effettuato entro i 26 anni di età. Negli adulti questo beneficio è, invece, minore, se non in situazioni particolari.
In ogni caso, occorre essere consapevoli che il vaccino protegge solo dai tipi di HPV che più di frequente causano condilomi e tumori, ma non da tutti: è perciò necessario in età adulta effettuare gli screening periodici raccomandati per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.
Così come resta sempre raccomandato l’uso del profilattico per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili: essere vaccinati contro l’HPV non significa essere protetti da tutte le infezioni a trasmissione sessuale.
medico e specialista in Farmacologia Clinica, ricercatore presso il Laboratorio per la Salute Materno Infantile dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, dove è responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia. Si occupa principalmente del monitoraggio dell’uso dei farmaci nei bambini e negli adolescenti e del trasferimento dell’informazione sull’impiego dei farmaci, in particolare per quanto riguarda la gravidanza, l’allattamento e l’età pediatrica, agli operatori sanitari e ai cittadini.
Immagine in apertura NazariyKarkhut /iStock