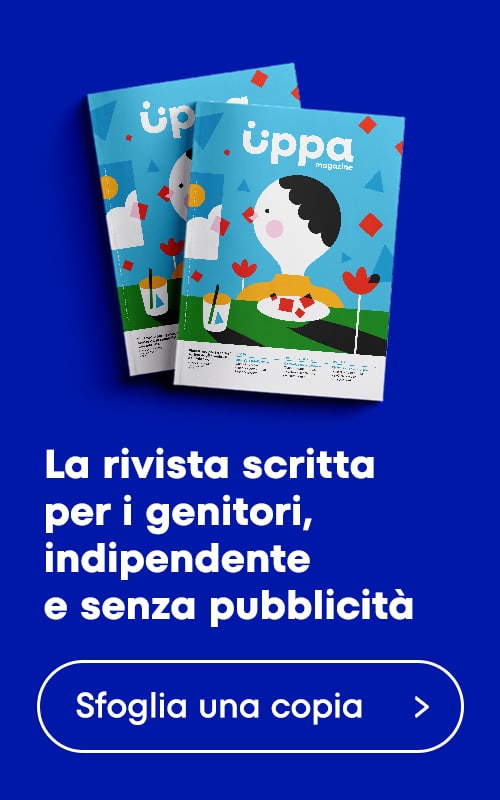Papilloma virus (HPV): come prevenirlo e curarlo
È un virus molto diffuso che comprende più di 200 genotipi, alcuni dei quali potenzialmente molto gravi. Rispondiamo alle domande più frequenti e vediamo perché è così importante informare le famiglie e i ragazzi sulla prevenzione e cura dell’HPV

Matilde e i suoi genitori sono dalla pediatra per il bilancio di salute che solitamente si esegue a 11 anni. La pediatra accenna al vaccino HPV per il papilloma virus. «Ma non è una cosa da adulti?», chiedono perplessi i genitori. «E poi l’HPV», aggiungono, «è davvero un pericolo per una bambina di questa età?».
Quelle dei genitori di Matilde sono domande molto comuni sul tema: l’HPV è un virus molto diffuso, ma sulla sua prevenzione e cura c’è ancora molta confusione. Facciamo chiarezza dando le risposte più utili a famiglie e ragazzi.
Cos’è il papilloma virus
L’HPV (Human Papilloma Virus, a volte chiamato anche HPV virus) non comprende un solo virus bensì oltre 200 genotipi. Alcuni causano delle semplici verruche sulla pelle (principalmente su mani e piedi), altri infettano le mucose dell’area genitale e della bocca/gola. I diversi genotipi vengono indicati con un numero e si dividono in categoria a basso rischio (come ad esempio i genotipi 6 e 11, legati spesso ai condilomi da HPV, ovvero piccole escrescenze morbide che possono variare in forma, dimensione e aspetto) e categoria ad alto rischio (i genotipi 16 e 18, fra i più associati a lesioni precancerose e tumori della cervice, ma anche dell’ano, del pene, della vagina, della vulva e dell’orofaringe, cioè della parte posteriore della gola).
La maggior parte delle infezioni si risolve da sola entro 1-2 anni, ma una quota può persistere e può dare problemi nel tempo evolvendo in lesioni precancerose e cancerose.
Papilloma virus e trasmissione
Il Papilloma virus come si contrae? L’HPV si trasmette principalmente tramite contatto diretto tra pelle e mucose. Il rischio è maggiore durante rapporti sessuali vaginali, anali o orali, ma può verificarsi anche con semplici contatti intimi senza penetrazione. Dunque non è vero che l’unico modo per contrarre il papilloma virus siano i rapporti sessuali completi.
Un domanda molto comune è: «Posso avere rapporti se ho l’HPV?». A tal proposito, è importante sottolineare che il virus può essere trasmesso per via sessuale, quindi prima di avere rapporti è importante confrontarsi con il/la partner e con il medico curante, in modo da valutare le modalità di protezione più adeguate e i tempi dei controlli da eseguire per entrambi.
Un’altra domanda frequente è: «L’HPV è contagioso anche con il preservativo?». Il preservativo riduce significativamente il rischio di trasmissione e va sempre utilizzato quando lo stato infettivo del partner non è noto. Tuttavia, non garantisce una protezione totale, perché non copre tutte le aree di contatto tra pelle e mucose. I dati epidemiologici mostrano che l’infezione può riguardare anche gli adolescenti, per questo la prevenzione a partire dagli 11-12 anni tramite vaccinazione è così importante: protegge dall’infezione prima dell’inizio dell’attività sessuale, riducendo drasticamente il rischio di lesioni e tumori futuri.
Quanto è pericoloso il papilloma virus?
Nella grande maggioranza dei casi, l’HPV non dà sintomi e sparisce da solo. Il problema nasce quando un ceppo ad alto rischio persiste: col tempo può infatti causare lesioni precancerose e, se non intercettate, tumori (della cervice uterina soprattutto, ma anche, come detto, dell’ano, del pene, della vulva/vagina, dell’orofaringe).
Ricordiamo che i programmi di screening (Pap o HPV test) servono proprio a intercettare presto queste lesioni e curarle prima che si trasformino in lesioni cancerose.
Si tratta quindi di un virus potenzialmente molto pericoloso, per questo è fondamentale prevenirlo attraverso il vaccino e gli strumenti di screening per una diagnosi precoce delle lesioni precancerose.
Infezione da Papilloma virus (HPV)
Le infezioni da Papilloma virus possono manifestarsi in vari modi.
Papilloma virus bocca/gola/lingua
Il contagio può avvenire tramite sesso orale; alcune infezioni orali sono asintomatiche, altre possono contribuire a lesioni dell’orofaringe nel lungo periodo. Non esiste uno screening di massa per queste zone, il consiglio è quindi quello di evitare comportamenti a rischio e vaccinarsi.
Papilloma virus utero
È l’area dove gli effetti dell’HPV sono più studiati: lo screening con Pap test e HPV DNA test individua alterazioni cellulari prima che diventino pericolose.
Papilloma virus e verruche
I condilomi (escrescenze “a cavolfiore”) sono spesso causati dai ceppi 6 e 11: sono benigni, ma fastidiosi e contagiosi; si trattano con farmaci topici o tecniche ablative.
Papilloma virus nella donna
Nelle donne, il Papilloma virus (HPV) può colpire l’area genitale, in particolare la vulva, la vagina e la cervice uterina. Nella maggior parte dei casi l’infezione non provoca sintomi evidenti e può passare del tutto inosservata: questo significa che “sentirsi bene” non è un criterio affidabile per escludere la presenza del virus. Proprio per questo lo screening periodico, attraverso Pap test o test HPV, rimane uno strumento fondamentale per individuare precocemente eventuali lesioni.
È importante ricordare che anche dopo la vaccinazione lo screening non deve essere sospeso: nessun vaccino, infatti, protegge contro tutti i ceppi del virus, e mantenere il controllo regolare è l’unico modo per garantire una diagnosi e un intervento tempestivi.
Papilloma virus nell’uomo
L’HPV non è un problema esclusivamente femminile: anche gli uomini possono contrarre e trasmettere il virus. Nei maschi, l’infezione può provocare la comparsa di condilomi genitali, lesioni dell’ano e, in casi più rari, tumori del pene e dell’orofaringe.
Spesso l’infezione è asintomatica, ma ciò non significa che sia innocua: anche senza sintomi, il virus può essere trasmesso e contribuire alla diffusione dell’infezione. Per questo motivo, la vaccinazione contro l’HPV è raccomandata anche ai ragazzi, così da proteggere non solo la loro salute, ma anche quella della comunità.
Papilloma virus e sintomi
Quali sono i sintomi dell’HPV? In realtà, nella maggior parte dei casi, l’infezione da Papilloma virus non provoca alcun disturbo evidente e può passare inosservata per molto tempo. Quando però compaiono dei sintomi, questi variano a seconda della zona colpita.
Nella regione genitale e anale, i segni più caratteristici sono i condilomi (o verruche genitali), piccole lesioni morbide che possono presentarsi isolate oppure raggruppate “a grappolo”. Di solito non sono dolorose, ma possono provocare prurito, fastidio o, talvolta, sanguinamento se irritate.
Quando interessa la cervice uterina (la localizzazione più comune), nelle fasi iniziali è quasi sempre asintomatico, motivo per cui lo screening con Pap test o HPV test è fondamentale; se la malattia è più avanzata, può provocare sanguinamenti anomali vaginali o dolore pelvico.
Quando l’HPV interessa la gola e il tratto orofaringeo, i sintomi sono meno specifici. Nelle fasi iniziali, infatti, l’infezione può rimanere a lungo asintomatica, il che ne rende più difficile l’individuazione precoce. Se la malattia progredisce, possono comparire raucedine persistente, dolore alla gola, difficoltà a deglutire (disfagia) o sensazione di corpo estraneo. In questi casi è fondamentale una valutazione clinica e, se necessario, l’invio a uno specialista per ulteriori indagini.
Papilloma virus e tumore
Alcuni ceppi di HPV, in particolare quelli ad alto rischio come il 16 e il 18, hanno un ruolo determinante nello sviluppo di lesioni precancerose. Queste lesioni possono comparire in varie sedi, ma la localizzazione più frequente è la cervice uterina, dove il virus può causare alterazioni cellulari che, se non individuate e trattate in tempo, possono evolvere in tumore.
Il tumore della cervice è uno dei più diffusi a livello mondiale tra le donne, ma oggi è prevenibile in gran parte dei casi grazie a due strumenti fondamentali: la vaccinazione e i programmi di screening (Pap test e HPV test).
La vaccinazione protegge dall’infezione dei ceppi più pericolosi, riducendo drasticamente il rischio di sviluppare lesioni. Lo screening, invece, permette di individuare precocemente eventuali alterazioni, quando sono ancora facilmente curabili. È importante sottolineare che questi strumenti non si escludono a vicenda, ma si completano: vaccinarsi non significa poter rinunciare ai controlli periodici, e viceversa.
Test per il Papilloma virus
Per diagnosticare un’infezione da HPV ad alto rischio e identificare eventuali lesioni precancerose, esistono diversi esami, che spesso si integrano tra loro:
- HPV test / HPV DNA test. Serve a individuare la presenza del DNA dei ceppi di HPV ad alto rischio oncogeno. In alcuni casi viene eseguita anche la genotipizzazione, cioè l’identificazione specifica dei ceppi più pericolosi, come il 16 e il 18, per definire meglio il percorso di follow-up.
- Pap test. Analizza le cellule prelevate dal collo dell’utero per verificare se presentano alterazioni morfologiche indicative di lesioni precancerose o di carcinoma.
- Colposcopia. È un esame di approfondimento che si esegue quando il Pap test o l’HPV test risultano positivi o anomali. Consiste nell’osservare la cervice uterina, la vagina e talvolta la vulva tramite un colposcopio, una lente d’ingrandimento dotata di luce. Durante l’esame, il medico può applicare specifiche soluzioni (acido acetico, soluzione di Lugol) per evidenziare eventuali aree sospette e, se necessario, effettuare biopsie mirate.
E se il Pap test è negativo ma l’HPV test è positivo? Questa combinazione indica che il virus è presente ma non ha ancora causato alterazioni cellulari visibili. In questi casi, il percorso successivo (controlli periodici, eventuale colposcopia) viene deciso in base all’età della donna, alla tipologia di HPV riscontrato e ai protocolli regionali di screening.
Cura per il papilloma virus
Attualmente non esistono farmaci in grado di eliminare direttamente il virus HPV dall’organismo. Il trattamento si concentra quindi sulle lesioni causate dall’infezione, quando presenti. Per i condilomi genitali si ricorre a creme o soluzioni ad azione locale (come imiquimod, acido tricloroacetico o podofillina) oppure a procedure fisiche come crioterapia, laser o elettrocauterizzazione. Spesso sono necessarie più sedute e le recidive non sono rare. Le lesioni cervicali vengono gestite con controlli ravvicinati oppure, nei casi indicati, con procedure escissionali. Nel frattempo, uno stile di vita sano e la sospensione del fumo possono supportare il sistema immunitario, facilitando il controllo spontaneo dell’infezione.
Dall’HPV ad alto rischio si guarisce?
Un’infezione da HPV ad alto rischio è curabile? Nella maggior parte dei casi, il sistema immunitario riesce a eliminare spontaneamente il virus entro uno-due anni. Quando invece le infezioni persistono e provocano lesioni, queste possono essere trattate con ottimi risultati, soprattutto se intercettate precocemente grazie a screening regolari. La vaccinazione gioca un ruolo fondamentale: protegge dai ceppi più pericolosi e riduce drasticamente il rischio di nuove infezioni, contribuendo così a prevenire lo sviluppo di lesioni precancerose o tumori.
Vaccino per il Papilloma virus
Il vaccino HPV in Italia è disponibile nella formulazione nonavalente, che protegge contro nove ceppi del virus (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), compresi quelli più associati a lesioni precancerose e tumori.
Il vaccino per il Papilloma virus è offerto ai maschi e alle femmine gratuitamente ed è raccomandato tra gli 11 anni compiuti e il compimento dei 12, con efficacia massima se la somministrazione avviene prima dell’inizio dell’attività sessuale. Lo schema prevede la somministrazione per via intramuscolare di due dosi, la seconda a distanza di 6-12 mesi dalla prima. Dopo i 14 anni di età sono previste tre dosi (la seconda a distanza di 2 mesi dalla prima e la terza a distanza di sei mesi dalla prima).
Anche chi ha già contratto un’infezione da HPV può comunque beneficiare del vaccino, che riduce il rischio di infezioni future da altri ceppi non ancora incontrati.
Per approfondire l’argomento e le modalità di somminsitrazione, vi consigliamo la lettura dell’articolo Vaccino per il papillomavirus: perché è importante proteggere soprattutto i giovani, di Antonio Clavenna.
Papilloma virus e gravidanza
Durante la gravidanza, le infezioni da HPV possono comportare alcune variazioni cliniche. I condilomi genitali, ad esempio, possono aumentare di dimensioni a causa dei cambiamenti ormonali e della maggiore vascolarizzazione della mucosa.
Il trattamento viene effettuato solo se necessario, privilegiando metodi locali e non invasivi per proteggere mamma e bambino.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il parto cesareo non è indicato di routine per l’HPV: viene preso in considerazione solo se le lesioni sono tali da ostacolare il parto o in casi particolari valutati dal ginecologo.
I vaccini contro l’HPV non vengono somministrati durante la gravidanza, ma possono essere recuperati dopo il parto. Ad ogni modo, in ogni situazione è fondamentale confrontarsi sempre con i professionisti che seguono la gestazione, per valutare il percorso più sicuro e appropriato.

Pediatra, nel 2024 ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Immunologia, Medicina Molecolare e Biotecnologie Applicate presso l’Università di Roma Tor Vergata. Attualmente lavora come Clinical Research Fellow presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove svolge attività clinica presso il Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico e attività di ricerca presso i laboratori dell’Unità di Terapia Cellulare e Genica delle Malattie Ematologiche.
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, “Papilloma virus e carcinoma cervicale”, ospedalebambinogesu.it, luglio 2024.
- Humanitas Research Hospital, “Infezione da HPV (Papilloma virus): diagnosi e trattamento”, humanitas.it.
- Istituto Mario Negri IRCCS, “Papilloma virus: cos’è, sintomi, cura e fattori di rischio”, marionegri.it, aprile 2023.
- Morris, Sheldon R.; Muzny, Christina A., “Infezione da papillomavirus umano (HPV)”, Manuale MSD (versione per i pazienti), febbraio 2023 (rev. aprile 2025).
- HSR – Humanitas Research, “Papilloma Virus: in cosa consiste e come si può curare”, hsr.it, luglio 2021.
Immagine in apertura Anchiy / iStock