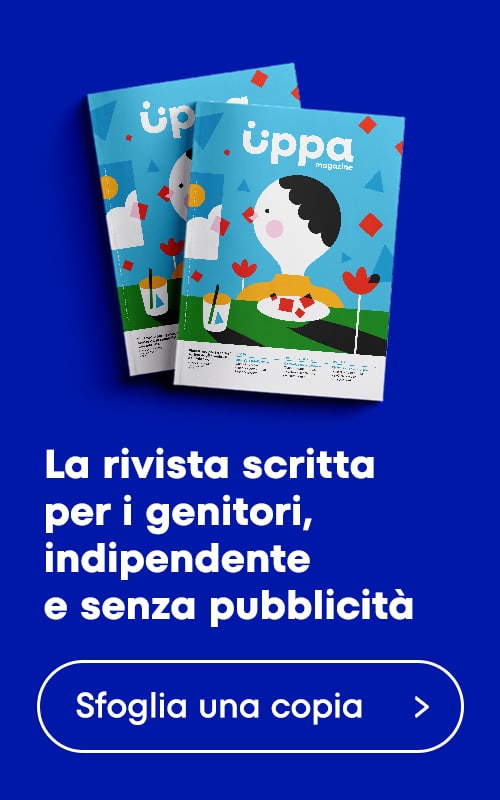Poliomielite: cos’è, come si trasmette e come proteggersi
Questa grave malattia infettiva, oggi rara grazie alla vaccinazione, resta una minaccia in alcune aree del mondo. Conoscerla è il primo passo per continuare a prevenirla in modo efficace

La poliomielite, spesso chiamata semplicemente polio, è una malattia altamente contagiosa di cui oggi si parla poco, soprattutto nei Paesi in cui la vaccinazione è obbligatoria e diffusa. Eppure, solo poche decine di anni fa, faceva molta paura. Questa malattia, infatti, che colpisce soprattutto i bambini, in alcuni casi può arrivare a causare delle paralisi permanenti.
Ma cos’è esattamente la poliomielite? Rappresenta ancora un rischio? E come possiamo proteggere i nostri figli? In questo articolo spieghiamo in modo semplice le caratteristiche di questa malattia, come si trasmette e qual è il ruolo fondamentale del vaccino nel contrastarla.
Il virus della poliomielite
La poliomielite è causata da un virus, chiamato Poliovirus, appartenente alla famiglia degli Enterovirus, che comprendono diversi virus capaci di infettare l’intestino. Ne esistono tre tipi principali (tipo 1, 2 e 3).
Il virus entra nel corpo per via orale e si moltiplica nell’intestino. In molti casi non dà sintomi particolari, ma in alcune persone riesce a raggiungere il sistema nervoso centrale e danneggiare i neuroni che controllano i muscoli, causando i suoi più temuti effetti.
Poliomielite: il contagio come avviene?
Oggi, la poliomielite colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai 5 anni che vivono nei Paesi con scarse infrastrutture per quanto riguarda l’acqua e scarsi livelli igienico-sanitari. Sebbene sia estremamente rara al di fuori di queste aree, la poliomielite rappresenta un rischio per le popolazioni con basse coperture vaccinali, anche nei Paesi industrializzati. Per questo è ancora molto importante sapere come si contrae la poliomielite.
Il virus è altamente contagioso, si trasmette soprattutto per via oro-fecale, il che significa che può passare da una persona all’altra attraverso il contatto con mani sporche, acqua o cibi contaminati. I bambini piccoli sono i più esposti, perché mettono spesso le mani o gli oggetti in bocca e perché, nei Paesi dove l’igiene non è garantita, il virus può circolare più facilmente. In alcuni casi, il virus può diffondersi anche con le secrezioni respiratorie come la saliva e le goccioline emesse con i colpi di tosse e gli starnuti da soggetti ammalati.
Un aspetto importante da sapere è che una persona infetta può trasmettere il virus anche se non ha sintomi: questo rende la poliomielite una malattia difficile da controllare, soprattutto nelle aree in cui la vaccinazione non è diffusa.
Sintomi della poliomielite
Nella maggior parte dei casi (circa il 70-95%), la poliomielite è asintomatica o genera solo pochi sintomi: il virus infetta l’intestino, ma non dà segni evidenti. A volte possono comparire sintomi lievi, simili a quelli di un’influenza, ovvero:
- febbre;
- stanchezza;
- vomito;
- mal di gola;
- mal di testa;
- nausea;
- dolori muscolari.
In alcuni casi può verificarsi una rigidità del collo o un malessere generale. I sintomi generalmente si risolvono completamente tra i due e i 10 giorni.
Conseguenze più serie si verificano invece quando il virus riesce ad attaccare il sistema nervoso. In una piccola percentuale di casi (intorno all’1%), la poliomielite invade il sistema nervoso centrale distruggendo le cellule che innervano i muscoli (detti motoneuroni) e può provocare una paralisi acuta, cioè una perdita improvvisa di forza in uno o più muscoli, spesso a un solo arto. In generale, la patologia ha effetti più devastanti sui muscoli delle gambe che su quelli della braccia. Le gambe perdono tono muscolare e diventano flaccide, una condizione nota come paralisi flaccida.
Conseguenze della poliomielite
Le conseguenze della poliomielite possono essere molto diverse da persona a persona. Nella forma paralitica, il danno ai nervi può portare a:
- paralisi permanenti di uno o più arti;
- deformità muscolo-scheletriche;
- dolori cronici;
- difficoltà nei movimenti e nella vita quotidiana;
- osteoporosi e fratture.
Questo tipo di paralisi può diventare permanente. Nei casi più gravi di poliomielite, possono essere colpiti i nervi cranici deputati alla deglutizione, alla parola e alla respirazione; la malattia, in questi casi, può essere anche letale.
In passato, la poliomielite ha colpito duramente molti bambini, costringendoli all’uso di tutori, stampelle o sedie a rotelle, e in alcuni casi rendendoli dipendenti dall’assistenza per tutta la vita.
Esiste poi una condizione chiamata sindrome post-polio, che può comparire anni o decenni dopo l’infezione: anche chi sembrava essersi ripreso può sviluppare stanchezza cronica, dolori e debolezza muscolare. Questa sindrome è rara, ma descritta in molti pazienti che hanno avuto la forma paralitica.
Come si cura la poliomielite?
Purtroppo, non esiste una cura specifica per la poliomielite. Come per molte malattie virali, la terapia è solo di supporto. Si possono trattare i sintomi, prevenire complicazioni e aiutare il recupero delle funzioni motorie, ma non si può eliminare il virus una volta che ha colpito il sistema nervoso.
Nel caso di paralisi, sono fondamentali la fisioterapia, la riabilitazione e, a volte, l’uso di ausili per la mobilità. Nei casi più gravi, quando sono compromessi i muscoli respiratori, può essere necessario il supporto ventilatorio.
Come si cura dunque la poliomielite? L’unica risposta valida è: la prevenzione. Il vaccino antipolio è l’unica strada per evitare le potenziali conseguenze del virus.
Poliomielite in Italia
Grazie alla vaccinazione di massa, l’ultimo dei casi di poliomielite in Italia risale al 1982. Da allora, il virus non circola più nel nostro Paese. Tuttavia, finché esiste una epidemia di polio in altre parti del mondo, il rischio di reintroduzione non può essere escluso. Per questo la vaccinazione contro la poliomielite è ancora obbligatoria, importantissima e inclusa nel calendario vaccinale.
Vaccino antipoliomielite
Il vaccino, come detto, è l’unico modo per prevenire la poliomielite. Esistono due tipi di vaccini diversi: quello “inattivato”, detto vaccino di Salk (vaccino IPV), da somministrare con iniezione intramuscolo, e quello “vivo attenuato” detto di Sabin (OPV), da somministrare per via orale. Il vaccino di Sabin, somministrato fino ad anni recenti anche in Italia, ha permesso di eradicare la poliomielite in Europa.
In Italia il vaccino anti poliomielite è obbligatorio. Dal 2002 si utilizza il vaccino inattivato (IPV), dato che non causa i rari effetti collaterali gravi possibili per il vaccino Sabin, e garantisce comunque un’ottima protezione. Il vaccino antipolio viene somministrato nei primi mesi di vita, non da solo ma all’interno del vaccino esavalente, che protegge anche da difterite, tetano, pertosse, Haemophilus Influenzae di tipo B ed epatite B.
Per una copertura duratura, oltre alla prima somministrazione è previsto un richiamo del vaccino antipolio in associazione a difterite, tetano e pertosse. Nel dettaglio, il calendario vaccinale prevede:
- prima dose a 3 mesi;
- seconda dose a 5 mesi;
- terza dose a 11-13 mesi;
- richiami a 5-6 anni e a 12-16 anni.
Dopo il ciclo primario nel primo anno di vita, la protezione è molto elevata e duratura. In alcuni casi (ad esempio per chi viaggia in aree a rischio), può essere consigliato un ulteriore richiamo in età adulta.
Il vaccino per la poliomielite è pericoloso? No, la vaccinazione che è proposta in Italia è sicura e ben tollerata. Il vaccino antipolio causa infatti pochi effetti collaterali. Si possono manifestare sintomi lievi come febbricola o dolore nella sede dell’iniezione. I benefici, invece, sono enormi: grazie alla vaccinazione di massa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità è riuscita a eliminare la poliomielite da quasi tutto il pianeta.
Anche se oggi la poliomielite può sembrare una malattia del passato, è importante non abbassare la guardia. Il virus esiste ancora in alcune parti del mondo e potrebbe tornare a circolare se smettessimo di vaccinarci. Per fortuna abbiamo un vaccino sicuro ed efficace, che protegge non solo i nostri figli ma anche la comunità.
Parlare di poliomielite significa ricordare quanto è stato importante il progresso medico e quanto sia ancora essenziale la prevenzione. Conoscere questa malattia, e sapere come evitarla, è il primo passo per continuare a tenerla lontana.

Pediatra di libera scelta nella provincia di Bologna, nella pratica clinica tratta principalmente le tematiche legate all’alimentazione, alla dermatologia e allo sviluppo in età pediatrica. Al di fuori dell’attività ambulatoriale, è autore di un manuale di pediatria rivolto ai giovani medici e collabora con Uppa dal 2024
- ISS, “Poliomielite”, epicentro.iss.it, novembre 2019.
- Jonathan G. Wolbert, Michael Rajnik, Helena M. Swinkels, Karla Higginbotham, “Poliomyelitis”, StatPearls, ottobre 2024.
Immagine in apertura FatCamera / iStock