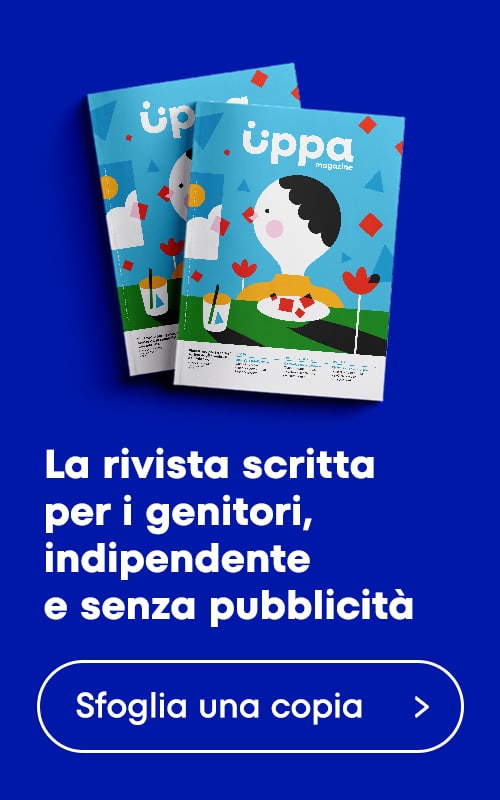Diarrea nei bambini: cause e cosa fare
Difficilmente la diarrea può provocare situazioni cliniche preoccupanti. Tuttavia se non viene trattata in maniera adeguata e non si presta attenzione alla comparsa di alcuni segnali, può essere potenzialmente pericolosa per la salute dei bambini

La diarrea, ovvero l’emissione di feci liquide o semiliquide con una frequenza aumentata rispetto alle comuni evacuazioni giornaliere, rappresenta un problema piuttosto frequente nei bambini e può essere potenzialmente pericolosa per la loro salute se non viene trattata adeguatamente. Si stima che quasi tutti i bambini al di sotto dei 3 anni, specie se frequentano il nido o la materna, vadano incontro ad almeno un episodio all’anno di diarrea.
Questo disturbo può essere isolato, ma più spesso si associa ad altri sintomi, quali vomito e febbre, configurando il quadro della gastroenterite acuta.
Le cause della diarrea nei bambini
Vediamo di seguito quali sono le più frequenti cause di diarrea nel bambino.
Infezioni virali o batteriche
Le infezioni virali risultano tra le più frequenti cause di diarrea nel bambino. I virus che possono determinare la diarrea sono numerosi, ma il più importante è il Rotavirus, responsabile di forme di enterite piuttosto severe.
La diarrea di origine batterica è invece molto meno frequente anche se più impegnativa e più difficile da trattare. I batteri comunemente coinvolti sono la Salmonella, il Campylobacter, la Shigella e l’Escherichia Coli.
Distinguere una forma batterica, che richiede una terapia specifica, da una forma virale, per cui invece l’unica terapia consiste nell’evitare la disidratazione, non è molto semplice; tuttavia, generalmente, le forme batteriche sono caratterizzate da sintomi sistemici quali febbre, malessere generale e presenza di sangue nelle feci.
Antibiotici
La diarrea da antibiotici è dovuta alla modifica dell’ecosistema intestinale: molti antibiotici alterano l’equilibrio della flora intestinale, con il rischio di favorire la crescita di batteri produttori di tossine che determinano la diarrea. È il caso, ad esempio, della diarrea da Clostridium difficile, poco frequente ma potenzialmente severa per il bambino.
Allergie alimentari
Causano diarrea soprattutto nei neonati e nei lattanti, che possono manifestare allergia alle proteine del latte vaccino o ad altri alimenti (uova, frutta secca, grano…).
Avvelenamento/intossicazione da cibo
Si verifica in seguito al consumo di cibi o bevande contaminate da batteri, virus, parassiti o sostanze chimiche nocive.
Diarrea nei bambini: cosa mangiare?
«Il mio bambino ha la diarrea, cosa posso fargli mangiare adesso?» L’alimentazione in caso di diarrea nei bambini è l’aspetto più importante da curare. La parola d’ordine in questi casi è “idratazione”, non esiste rimedio più importante: il bambino, infatti, deve recuperare i liquidi e i sali minerali che perde con le feci.
Se il piccolo è allattato al seno sarà fondamentale proseguire l’allattamento, rispondendo alle sue richieste che in genere sono più frequenti, attaccandolo dunque anche più spesso del solito, proprio perché avverte più sete. Peraltro, il latte materno svolge un’importante funzione immunologica e contribuisce a eliminare i germi che causano il disturbo.
Se il bambino assume una formula artificiale invece del latte materno, la dieta non dovrà essere variata: sarà bene proseguire con i consueti pasti, senza diluire maggiormente il latte con la falsa credenza che in questo modo il bambino venga idratato meglio (con questo sistema si offre una quota minore di calorie in un momento in cui il piccolo potrebbe chiederne anche più del solito).
Se siamo già in una fase di alimentazione complementare, cosa dare ai bambini con la diarrea? Non c’è ragione di variare la dieta abituale. Gli studi scientifici hanno infatti dimostrato che i bambini guariscono prima se viene mantenuta una dieta libera; la famosa dieta “in bianco” quindi non solo non è utile, ma è controproducente in quanto limita le assunzioni caloriche e favorisce il prolungarsi della diarrea. Tuttavia è sempre opportuno ricordare che se il bambino non ha voglia di mangiare non è necessario forzarlo: è importante curare soprattutto l’idratazione e proporre al massimo pasti piccoli ma frequenti.
E le soluzioni reidratanti? Ce ne sono moltissime in commercio, anche in diverse formulazioni (polvere da sciogliere, compresse solubili, brik già pronti all’uso), e in generale quasi tutte sono molto utili per consentire al bambino di idratarsi e reintegrare la quota di sali minerali persi. Spesso sono anche addizionate con carboidrati complessi per consentire al piccolo di recuperare energie. Un consiglio: essendo ricche di sali, hanno spesso un sapore poco gradevole; provate a refrigerarle, acquisiranno così un sapore più appetibile.
È meglio evitare che…
- È meglio evitare che il piccolo resti a digiuno per un tempo eccessivo: contrariamente a quanto si pensava in passato, “mettere a riposo l’intestino” non solo non è necessario, ma può essere anche controproducente perché debilita ulteriormente il bambino.
- È meglio evitare l’assunzione di zuccheri semplici, anche sotto forma di bevande: non proporre succhi di frutta o bevande gassate, tisane o infusi zuccherati, in quanto andranno a incrementare il numero e il volume delle scariche.
- È meglio evitare cibi ricchi di fibre o alimenti integrali e cibi particolarmente lavorati (insaccati).
E il latte?
Un discorso a parte va fatto per questo alimento così importante per i bambini. Come già detto, per il bambino al di sotto dell’anno di età, che ancora assume latte materno o formulato, non sarà opportuno variare lo schema alimentare.
Il bambino più grande invece trarrà giovamento da una riduzione dell’apporto dei latticini freschi e del latte in particolare, perché in situazioni di infiammazione intestinale si realizza un deficit enzimatico che porta a un’alterata digestione del lattosio, con conseguente incremento del numero delle scariche.
Se, però, offrire piccole quantità di latte rappresenta l’unico modo per reidratare un bambino ancora piccolo, occorre valutare con il pediatra l’opportunità di offrire per qualche giorno un tipo di latte specifico per le situazioni di enterite.
Rimedi per la diarrea: quali soluzioni?
Esistono dei rimedi per la diarrea nei bambini? È bene anzitutto ricordare che stiamo parlando di un meccanismo di difesa del nostro organismo: la diarrea, infatti, serve a eliminare il germe o la tossina che causa l’infiammazione della mucosa intestinale. Dunque è importante non bloccare la diarrea nei bambini utilizzando farmaci. Peraltro, la diarrea acuta è una patologia autolimitante, ovvero un malanno con un decorso blando e benigno che tende a risolversi in modo spontaneo. Se dunque si instaurano un buon regime alimentare e una buona idratazione, non ci sarà nulla da temere e si potrà aspettare pazientemente la naturale remissione.
Ecco di seguito alcune possibili soluzioni per la diarrea nei bambini, da utilizzare solo se prescritte dal pediatra:
- Probiotici. Comunemente conosciuti come “fermenti lattici”, rappresentano di gran lunga il rimedio più diffuso. Ne esistono di tanti tipi diversi, ma bisogna porre molta attenzione perché sono pochi i ceppi batterici realmente efficaci. È bene farsi sempre consigliare dal medico di fiducia per non incappare nella somministrazione di un probiotico che potrebbe rivelarsi inutile. Fra i diversi probiotici, la letteratura scientifica supporta in modo particolare il Lactobacillus rhamnosus, il Lactobacillus reuteri e il Saccharomyces boulardii.
- Antisecretivi. Consentono di ridurre la quota di acqua persa a ogni scarica. Sono tanto più efficaci quanto prima viene instaurato il trattamento. Attualmente il farmaco antisecretivo maggiormente consigliato dalle società scientifiche specializzate è il Racecadotril.
- Tannini. Sono fra i prodotti di più recente utilizzo (anche se il loro ruolo fitoterapico è noto da tempo). Esplicano un importante ruolo antinfiammatorio nei confronti della mucosa intestinale, favorendo il processo di guarigione.
Quando preoccuparsi della diarrea dei bambini?
La diarrea nei bambini quanto dura? Generalmente la durata di questo disturbo è di pochi giorni o comunque meno di due settimane.
Se adeguatamente gestita, anche semplicemente con l’aiuto telefonico del pediatra, difficilmente la diarrea può provocare situazioni cliniche preoccupanti. Tuttavia, è bene evitare la disidratazione, e a tal proposito occorre prestare attenzione ai seguenti segnali:
- la pelle appare secca, perde la consueta elasticità ed è sollevabile in pliche;
- le mucose sono asciutte con lingua secca e labbra screpolate;
- la diuresi è contratta, ovvero il piccolo fa poca pipì e molto concentrata;
- il bambino appare poco attivo, privo di energie, talvolta anche sonnolento;
- il respiro è rapido e superficiale.
Se sono presenti anche solo alcuni di questi segnali è opportuno far visitare nell’immediato il bambino.
Diarrea nei bambini: prevenzione
La prevenzione della diarrea nei bambini passa dalle comuni norme igienico-sanitarie. Infatti, la causa più comune di diarrea è quella infettiva, per cui bisogna educare i bambini a lavarsi spesso le mani, specie prima dei pasti o dopo che si è usato il bagno.
Occorre lavare accuratamente anche la frutta e la verdura, specie se si decide di consumarle crude. La carne va cotta sempre in maniera adeguata. È inoltre fondamentale controllare sempre con molta attenzione la qualità degli alimenti prima del consumo.
Una menzione particolare va fatta nei riguardi del vaccino anti-Rotavirus, che ormai in maniera piuttosto diffusa viene proposto entro le prime 24 settimane di vita. Tale pratica vaccinale, sicura ed efficace, ha contribuito largamente a ridurre l’incidenza della diarrea da Rotavirus nella popolazione infantile.
In conclusione, la diarrea è un sintomo tanto frequente quanto fastidioso, ma se adeguatamente conosciuto e opportunamente gestito non deve destare preoccupazione per i genitori né provocare un eccessivo disagio per il bambino.
- Franco Panizon, La diarrea acuta, «Medico e Bambino», 2005;24(6):385-387.
- Deborah M. Consolini, Diarrea nei bambini, «Manuale MSD», giugno 2020.
- Società Italiana di Pediatria, La gastroenterite acuta, «sip.it», settembre 2017.
- AA.VV., European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014, «J Pediatr Gastroenterol Nutr», luglio 2014;59(1):132-52.
Immagine in apertura AleksandarNakic / iStock