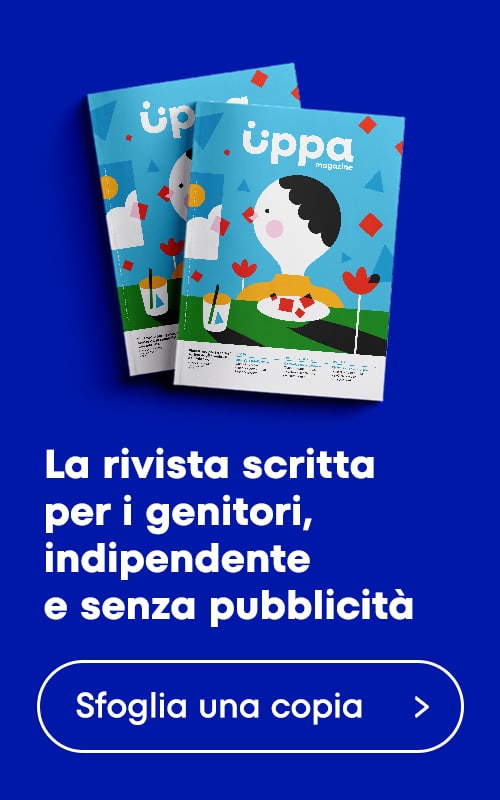Genitori imperfetti?
Il rapporto con i nostri figli è messo alla prova dai profondi cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Non cerchiamo di essere genitori “perfetti”, ma accogliamo e comunichiamo le emozioni, educando i bambini al rispetto e all’empatia

«Non vorrei reagire così, ma…»: è frequente che un genitore si senta in colpa per una reazione troppo brusca, una sgridata un po’ ingiusta, una richiesta che forse è eccessiva rispetto all’età del bambino o alla situazione. O che faccia fatica ad accettare di “non avere voglia” di fare tutte quelle belle cose che i bravi genitori fanno sempre e comunque, anche se sono stanchi, nervosi, sfiniti: ascoltare quello che il bambino dice, rispondere a tono, dialogare, comprendere, accogliere… e poi leggere con lui, commentare quello che si vede in TV, proporre attività interessanti, sedare i conflitti tra fratelli.
Diciamolo: anche in tempi normali è difficile (magari impossibile?) mantenere questo standard di perfezione senza rischiare di aumentare il livello di stress che un autocontrollo del genere comporta, con la conseguente possibilità di un’esplosione incontrollata.
In tempi di Coronavirus ignorare i propri limiti o percepirli come una colpa può rendere davvero troppo faticoso il compito di “fare i genitori”
Con cosa abbiamo a che fare?
Se riflettiamo su ciò che caratterizza questo momento della vita di tutti noi, ci rendiamo conto che si tratta di cambiamenti: una quantità del tutto anomala, inabituale, imprevedibile di cambiamenti.
I cambiamenti sono una cosa bella solo quando dimostrano di esserlo: quando producono effetti positivi, il più possibile vicini a quello che volevamo veder succedere; quando almeno in parte sono scelti e desiderati da noi.
Non è quello che stiamo vivendo oggi. Se facciamo un elenco di tutto ciò che è cambiato – e ognuno può completarlo in base all’esperienza specifica della propria famiglia – ci accorgiamo che per ora i vari cambiamenti hanno significato la perdita di qualcosa:
- Sono cambiati i ritmi di vita
- È cambiata la suddivisione degli spazi
- Sono cambiati i rapporti con le persone esterne alla famiglia
- Sono cambiate le occasioni di fare cose piacevoli, di dedicarsi alle attività che ci appassionano
- Sono cambiati i compiti e le richieste all’interno della famiglia
E abbiamo perso libertà, autonomia, possibilità di scelta, contatti, socialità, in troppi casi anche sicurezza economica.
A tutto ciò, poi, si sommano i cambiamenti nelle emozioni che proviamo: la speranza, che ha caratterizzato i primi giorni di confronto con questa esperienza, viene pian piano sostituita dall’incertezza, dalla paura, dalla preoccupazione; e anche dal dolore e dalla rabbia, soprattutto per chi è toccato più da vicino dall’emergenza, perché lavora nei servizi sanitari e sociali o perché ha familiari e amici malati o morti. Un gruppo di ricerca sta monitorando questi cambiamenti emotivi, che ultimamente tendono sempre più verso la tristezza e l’irritazione. Sentimenti che accomunano, sia pure con manifestazioni diverse, gli adulti e i bambini.
Le reazioni dei bambini
Ed ecco che i bambini possono diventare “capricciosi” (più capricciosi); cercare maggiore attenzione, rassicurazione, un rapporto esclusivo con i genitori; aver bisogno di compagnia per un tempo sempre più lungo al momento di addormentarsi; perdere autonomia, regredire, utilizzare parolacce, evitare gli impegni, non accettare di svolgere i compiti che vengono loro assegnati.
Dobbiamo ammettere che, per quanto comprensibili, questi comportamenti possono essere irritanti, e che essere a contatto con atteggiamenti simili senza interruzione, ora dopo ora, giorno dopo giorno, può rendere davvero difficile tollelarli.
C’è un altro aspetto da considerare: l’interazione fra adulto e bambino è un’interazione “non paritaria”. La consapevolezza che i “grandi” siamo noi, che a un bambino non si possono dire e chiedere le stesse cose che si dicono e si chiedono a un adulto, obbliga a una comunicazione più controllata, “adattata” a una relazione di diverso tipo. La perdita totale o parziale delle relazioni fra adulti – in cui il nostro ruolo non è quello del papà o della mamma, in cui è consentita una gamma molto più ricca di “giochi” relazionali – può provocare quel senso di insoddisfazione, di frustrazione, che molti avvertono in questi giorni, e influire in modo significativo sull’umore e sulla disponibilità nei confronti dei familiari.
Autenticità batte perfezione dieci a zero
«Mia figlia mi sta continuamente appiccicata», dice la mamma di una undicenne abitualmente autonoma e indipendente. «Dovrei capirla, è un momento difficile per tutti, ma a volte finisce che la sgrido, la spingo proprio via, le dico di piantarla, e poi mi dispiace». Un’altra mamma: «Il mio bambino comincia ad avere paura di tutto, adesso non vuole più uscire nemmeno in cortile, e io mi accorgo di non sopportarlo più quando fa queste scene, mi viene da urlargli di non fare il cretino, che di cretini ce ne sono già abbastanza in circolazione».
La domanda, espressa o sottintesa in questi racconti, è: «Sono un cattivo genitore?».
Domanda che se ne porta dietro altre: «Come dovrei essere, invece?» o «Cosa dovrei fare per non reagire così?».
Sono domande che implicano la possibilità di fare una cosa impossibile, anzi dannosa: imporsi di non sentirci come ci sentiamo. Dovremmo far finta di non essere irritati, stanchi, nervosi? Impedire ai bambini di accorgersene? Negare, se necessario?
C’è una cosa che ripeto sempre ai genitori: i bambini non sono statuine fragili che non sono in grado di sopportare gli urti della vita. Trattarli come se lo fossero sottrae loro la possibilità di confrontarsi con la realtà, di mettere in gioco tutte le proprie risorse, di esercitarle e svilupparle per imparare a “stare” in un mondo che non è sempre e solo facile, rassicurante, comprensivo e protettivo. I genitori hanno il compito di non lasciare soli i bambini, di sostenerli e di incoraggiarli, ma non di distanziarli dalla realtà con strati e strati di ovatta protettiva. Dovrebbero aiutarli a sviluppare l’empatia, che è la capacità di dare senso ai comportamenti degli altri anche quando non sono perfetti, imparando così a tollerarli.
Condividere con i figli una situazione piena di limitazioni, in cui siamo privati di libertà che consideravamo intoccabili, può essere un’occasione di educazione emotiva, a patto di conservare l’autenticità. Si può (si deve) parlare del fatto che le esigenze di una persona, quando i contatti sono troppo stretti e prolungati, finiscono per scontrarsi con le esigenze delle altre. Che un comportamento può essere sopportabile fino a un certo punto e poi non esserlo più. Che dire «basta, mi hai stufato» è un diritto, e che ognuno deve sforzarsi di prendere atto delle reazioni altrui, e imparare a modulare i propri comportamenti in base a esse.
È meglio un «basta, mi hai stufato», detto appena l’irritazione compare, che uno sfogo di nervi quando diventiamo “troppo pieni”. È meglio pretendere un momento di pausa in cui potersi isolare da tutti («Ragazzi, vi chiedo mezz’ora di pausa: io non ci sono, non vedo, non sento, non parlo; voi non mi parlate. Se no prima o poi mordo qualcuno») piuttosto che arrivare a una sfuriata rivendicativa in cui si elencano tutte le fatiche che abbiamo dovuto sopportare nel corso della giornata.
Il diritto a essere imperfetti
Così come non esistono bambini perfetti non esistono nemmeno genitori perfetti. Dunque stiamo tranquilli: se qualche volta arriviamo allo sfogo di nervi o alla sfilza di rivendicazioni non c’è bisogno di preoccuparsi. Se non diventa lo stile abituale della relazione con i nostri figli, non rischiamo di danneggiare nessuno. Ci sono mille modi per “riprendere i contatti” dopo una sfuriata, e sarà importante dichiarare anche il diritto all’imperfezione. Ogni genitore troverà il suo stile, da quello autoironico a quello più affettuoso, fino all’invenzione di un rituale di “fine sfuriata” che si può condividere con i bambini e che li aiuterà a loro volta a recuperare la calma, dopo uno scatto nervoso o un conflitto più acceso del solito.
Insomma, in tempi di inquietudine e di paura cerchiamo di evitarci almeno un timore: quello che se non saremo perfetti danneggeremo i nostri figli. Ricordiamo che la vita li metterà a confronto con amici imperfetti, fidanzati imperfetti, colleghi imperfetti, e anche con la loro stessa imperfezione. Se imparano a tollerarla – la propria e quella degli altri – saranno adulti più equilibrati.

psicologa, psicoterapeuta della famiglia e docente di counselling alla Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Torino, ha elaborato il metodo del counselling sistemico narrativo, che utilizza nella formazione dei professionisti e negli interventi per lo sviluppo delle competenze genitoriali. Ha fondato la scuola di comunicazione e counselling CHANGE di Torino.
Immagine in apertura fizkes / iStock