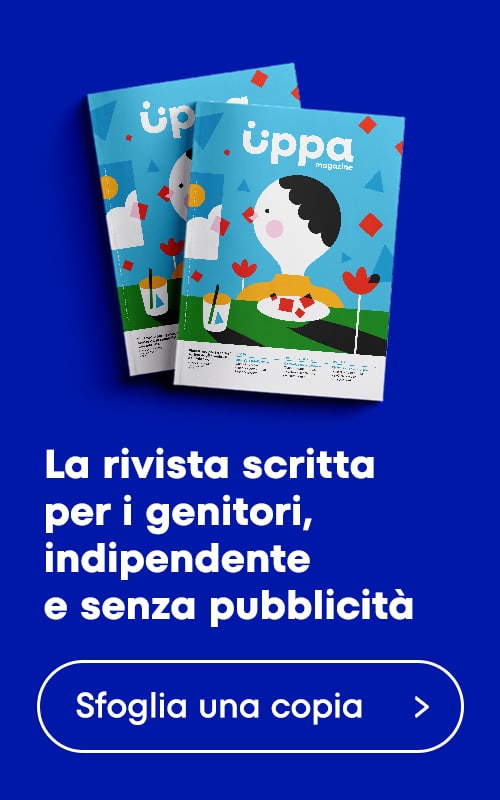Varicella: quanto è pericolosa?
Ogni tre o quattro anni le scuole si riempiono di questa famosa malattia: scopriamo cos’è e quali sono i pericoli, imparando a conoscerne le cause, le modalità di contagio, i tempi di incubazione e i trattamenti da utilizzare

La varicella, malattia infettiva acuta causata dal virus Varicella-Zoster (VZV), si manifesta con l’esantema pruriginoso caratteristico, spesso in forma lieve nei bambini, ma può essere più grave in adulti, gestanti o immunocompromessi. Il contatto diretto o le goccioline respiratorie consentono una trasmissione elevata, rendendola una malattia altamente contagiosa.
In Italia, il vaccino contro la varicella è obbligatorio per i nati dal 2017 (legge Lorenzin), disponibile nelle versioni monovalente o in combinazione nel vaccino MPRV quadrivalente. Questo approccio vaccinale sostiene la strategia di immunità di gregge.
La varicella è una malattia infettiva causata dall’herpes zoster virus (HZV), uno degli otto herpes virus conosciuti (tra gli altri troviamo quelli che causano la sesta malattia e la mononucleosi), ed è caratterizzata da vescicole sparse su tutto il corpo (le classiche bolle da varicella). Dopo la malattia, il virus rimane nel nostro organismo per tutta la vita (nei nervi periferici) e si risveglia nel 10-20% delle persone (solitamente sopra i 50 anni di età) per dar luogo all’herpes zoster, anche noto come fuoco di Sant’Antonio. Quest’ultimo si manifesta con vescicole localizzate solo in una zona circoscritta della pelle (in genere al torace) o comunque lungo il decorso di un nervo, accompagnate di solito da molto dolore.
Contagio
La varicella è molto contagiosa, arrivando a infettare fino al 90% di chi non ha mai avuto contatto con l’herpes zoster virus. Il contagio della varicella avviene attraverso la saliva del malato o per contatto diretto con il liquido che esce dalle vescicole quando queste si rompono.
Incubazione
Dal giorno del contatto con il soggetto malato di varicella passano tra i 14 e i 21 giorni prima che si manifesti la malattia, mentre il periodo di contagio inizia due giorni prima del manifestarsi delle prime vescicole.
Reinfezione
Nei paesi in cui gran parte della popolazione viene vaccinata si registrano alcuni casi di ricomparsa della varicella, o di herpes zoster in bambini mai vaccinati. Il motivo è molto semplice. Come detto, l’herpes zoster virus rimane nell’organismo dopo la varicella, e affinché non crei problemi il nostro sistema immunitario deve poter venire a contatto con il virus di altri malati, in modo da mantenere alti i livelli di protezione anticorpale. La vaccinazione ha ridotto sensibilmente la diffusione dell’HZV in alcune regioni, rendendo più difficile questo lavoro di controllo da parte del sistema immunitario. Ecco perché il virus torna a riattivarsi, determinando un herpes zoster (il fuoco di Sant’Antonio appunto) o, più raramente, una nuova varicella.
Sintomi
Durante lo stadio iniziale della varicella, 14-21 giorni dopo il contagio, può comparire un po’ di febbre, malessere, inappetenza, mal di gola. In seguito, dopo uno-due giorni ulteriori, la varicella si manifesta con il classico esantema: a cominciare dal tronco e dalla nuca e poi su tutto il resto del corpo, la pelle si riempie di tante piccole papule rosa pruriginose (sembrano pizzichi di zanzara), che rapidamente si trasformano in vescicole simili a piccole gocce di acqua. Successivamente, le vescicole si gonfiano fino a rompersi, trasformandosi in croste.
L’eruzione avviene in gettate successive, per cui papule, vescicole e croste sono presenti contemporaneamente nei primi tre-quattro giorni di malattia.
Varicella lieve
Generalmente, nei bambini che godono di buona salute, la varicella ha un andamento piuttosto lieve, in forma leggera, ossia con poche decine di vescicole, senza febbre e con scarso prurito.
Durata
Dopo quattro giorni dall’esordio non compaiono più né papule né vescicole, e intorno al settimo giorno sono presenti solo le croste, che cadono entro una-due settimane e possono lasciare una pelle più chiara.
Nei bambini o nei soggetti che si contagiano da qualcuno dei familiari stretti, la varicella tende ad avere un decorso più violento, con molte più vescicole e maggiore prurito.
I sintomi di possibili complicanze della varicella, per cui è necessario chiamare il medico, sono i seguenti: tosse, forte mal di testa, stato confusionale, nausea e vomito, disturbi dell’andatura (atassia). Il gonfiore e l’arrossamento di aree di pelle associati a forte dolore possono far sospettare una complicazione cutanea (sovrainfezione).
Adulti e immunodepressi
Negli adulti, negli adolescenti e nei soggetti con deficit immunitari (persone con infezione da HIV o sottoposte a chemioterapia o in cura con cortisone) la varicella ha un decorso più importante. Possono infatti verificarsi superinfezione batterica delle lesioni cutanee, calo delle piastrine, artrite, epatite, encefalite, polmonite e glomerulonefrite (malattia infiammatoria che interessa i reni). Inoltre, negli adulti, ogni 400 casi si manifesta una polmonite molto grave.
Per tutti questi motivi, i soggetti adulti e adolescenti che non hanno ancora avuto la varicella dovrebbero sottoporsi alla vaccinazione.
In gravidanza
La varicella contratta da una donna durante i primi due trimestri di gravidanza può trasmettersi al feto, causando raramente delle anomalie (sindrome della varicella congenita). Se il bambino nasce entro sette giorni dall’esordio della varicella nella madre, oppure se la madre sviluppa l’eruzione cutanea fino a sette giorni dopo il parto, può verificarsi una forma grave di varicella del neonato che necessita di un adeguato trattamento.
Trattamento
Nei bambini sani di età inferiore ai 12 anni, la terapia è solo rivolta a ridurre il disagio dovuto ai sintomi: per il prurito causato dalla varicella sono utili gli antistaminici, mentre si usa il paracetamolo per dolori e malessere. I bambini malati di varicella non devono essere trattati con salicilati (aspirina) perché ciò aumenterebbe il rischio di una malattia grave detta Sindrome di Reye. È bene evitare anche l’ibuprofene perché potrebbe favorire concomitanti infezioni da streptococco.
Nei casi più a rischio di complicanze (adolescenti affetti da dermatite atopica o con malattie respiratorie croniche o in trattamento con cortisone), nei casi secondari familiari o quando ritenuto opportuno dal pediatra, si può ricorrere a farmaci antivirali come l’acyclovir. Questo farmaco è maggiormente efficace se viene preso entro le prime 24 ore dalla comparsa delle vescicole. Nei pazienti immunodepressi è invece raccomandata la terapia antivirale per via venosa.
Tenere le unghie corte eviterà lesioni conseguenti al grattamento della pelle, mentre docce rapide e tiepide con bicarbonato saranno utili soprattutto quando la pelle è sudata e pruriginosa.
Vaccino
Il vaccino contro la varicella è molto efficace e viene somministrato singolarmente (vaccino monovalente) oppure all’interno del vaccino tetravalente MPRV, che protegge anche da morbillo, parotite e rosolia. L’età migliore per effettuarlo è tra i 12 e i 15 mesi; una seconda dose intorno ai 5-6 anni. Non è invece indicato in gravidanza e nei soggetti immunodepressi, perché fatta con un virus vivo attenuato.
Il 20% circa dei bambini che riceve una dose di vaccino contro la varicella sviluppa una reazione cutanea molto più attenuata rispetto alla classica varicella, e una lieve febbre. I soggetti vaccinati corrono anche un rischio inferiore di ammalarsi del fuoco di Sant’Antonio.
In generale, dunque, la vaccinazione è indicata in tutti i bambini sani e negli adolescenti e adulti che non si sono mai ammalati di varicella. In questo momento in Italia è obbligatoria per tutti i nati a partire dal 2017.
Poiché in Italia il 12-13% delle donne non ha avuto la varicella, la vaccinazione è fortemente indicata anche per le donne che vogliono intraprendere una gravidanza e che risultano negative alla ricerca degli anticorpi antivaricella (sarà però importante evitare la gravidanza fino al mese successivo alla vaccinazione).
Prevenzione
Se una persona che non ha mai avuto la varicella viene a contatto con una persona ammalata tra i due e i cinque giorni dopo la comparsa dell’esantema, ha il 90% di probabilità di ammalarsi a sua volta (dopo circa due-tre settimane). La vaccinazione di questi soggetti suscettibili entro 72 ore (max 120 ore) dal contagio può prevenire o modificare il decorso della malattia.
I soggetti immunodepressi e a rischio di sviluppare gravi conseguenze (come i neonati) devono ricevere per via intramuscolare quanto prima (fino a 96 ore dopo il contagio) le immunoglobuline specifiche antivaricella.
Ritorno a scuola
Secondo le normative vigenti (Circolare del Ministero della Salute n.4 del 13/03/98), un bambino che ha avuto la varicella può rientrare in comunità dopo 7 giorni dall’inizio dell’esantema. In presenza di complicazioni o di altri sintomi, sarà invece il vostro pediatra a consigliarvi il giusto tempo.
FAQ
Come sono cambiati i casi di varicella in Italia con l’introduzione del vaccino?
Dopo l’inizio delle campagne vaccinali, l’incidenza annua di varicella in Italia è significativamente diminuita.
Quali rischi corre il feto o il neonato se la mamma contrae la varicella durante la gravidanza?
Se una donna incinta contrae la varicella nei primi due trimestri, c’è un rischio (circa 2 %) di sindrome congenita, che può comportare anomalie nervose, oculari, cutanee o scheletriche. Se l’infezione materna avviene nel periodo che va da 5 giorni prima a 2 giorni dopo il parto, il neonato può sviluppare varicella neonatale grave. In questi casi, il pediatra può valutare l’uso di immunoglobuline specifiche.
Quando è veramente contagiosa la varicella, e per quanto tempo lo resta?
La varicella è altamente contagiosa: fino al 90% dei contatti in stretta prossimità si può infettare se non è immune. Il periodo di contagio inizia 2–3 giorni prima della comparsa dell’esantema e si protrae fino a quando tutte le lesioni non diventano croste, in genere 4–5 giorni dopo.
Quanto è efficace il vaccino contro la varicella e perché è importante farlo?
Il vaccino a virus attenuato è molto efficace: una dose previene circa il 95% delle forme moderate e il 100% delle forme gravi. La vaccinazione di massa aiuta a proteggere anche chi non può essere vaccinato, abbassando la circolazione del virus nella comunità.

nato a Roma, dove si specializza in Pediatria e frequenta il dottorato di ricerca. È membro dell’Associazione Culturale Pediatri e del gruppo Pediatri per Un Mondo Possibile. È coautore dei libri “Il bambino disattento e iperattivo” (Franco Angeli) e “Mangiare per crescere. Consigli per genitori in gamba” (Il Pensiero Scientifico).
- Mary A. Albrecht, Clinical features of varicella-zoster virus infection: Chickenpox, «UptoDate», 2019.
- Mary A. Albrecht, Treatment of varicella (chickenpox) infection, «UptoDate», 2019.
- EpiCentro, Varicella, «www.epicentro.iss.it».
- American Academy of Pediatrics, Varicella (Chickenpox), «www.healthychildren.org», 21 novembre 2015.
- David W. Wareham, Herpes zoster, «BMJ», 7 giugno 2007, n. 334, pp. 1211-1215.
Immagine in apertura Mixmike / iStock