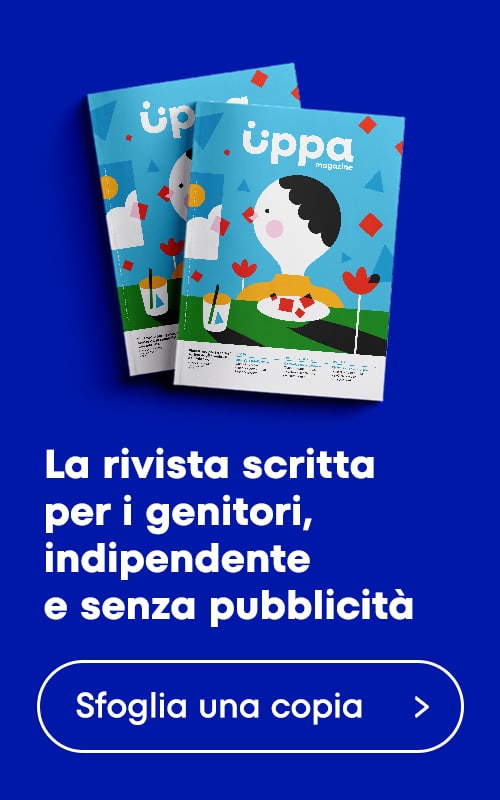Scarlattina: cause, sintomi e trattamento nei bambini
È l’unica tra le malattie esantematiche a essere causata da un batterio e non da un virus. Pur essendo una patologia quasi mai pericolosa, se non adeguatamente trattata può comportare conseguenze a lungo termine con il rischio di danni ai reni o al cuore

I genitori di Giada ricevono un messaggio dalla mamma di Carlotta, che ieri ha ospitato tutti i bimbi a casa per la festa di compleanno: Carlotta ha la febbre, mal di gola e delle macchie rosse, e la pediatra dice che potrebbe trattarsi di scarlattina. Giada al momento sta bene ma i suoi genitori sono già nel panico…
Esattamente, cos’è la scarlattina? Colpisce solo i bambini più grandi o anche i neonati? E gli adulti? Vediamo insieme le cause e i sintomi di questa infezione e come affrontarli senza allarmismo.
Cos’è la scarlattina e quali sono le cause?
Quali sono le cause della scarlattina? La scarlattina è un’infezione causata dallo streptococco beta-emolitico di gruppo A (SBEGA) ed è l’unica tra le malattie esantematiche a essere causata da un batterio e non da un virus. I tipi di SBEGA capaci di causare la scarlattina sono quelli che producono e rilasciano nel nostro corpo delle tossine capaci di far salire la temperatura corporea e di causare il caratteristico esantema cutaneo della patologia.
Ma come si prende la scarlattina e come fa, questa infezione, a essere così contagiosa? Lo SBEGA risiede nella faringe del soggetto malato e viene trasmessa per via aerea: le goccioline prodotte starnutendo, tossendo o anche semplicemente parlando portano con sé il batterio e possono dunque infettare le vie aree di chi si trova nelle immediate vicinanze.
La scarlattina non è una malattia propriamente stagionale e può verificarsi tutto l’anno, con un picco di incidenza nel tardo inverno e in primavera. Può colpire a tutte le età ma è più frequente nei bambini tra i 5 e i 15 anni. La scarlattina negli adulti e nei bambini al di sotto dei 3 anni è invece più rara.
I sintomi della scarlattina
Quali sono i sintomi della scarlattina? All’inizio sono quelli di una comune influenza, con febbre – spesso alta, attorno ai 38-40° – e mal di gola, senza alcuna macchia sulla pelle (viene infatti chiamata fase pre-esantematica) per cui porre il sospetto di scarlattina, quando non si ha la certezza di una precedente esposizione, è molto difficile.
Dopo 24-48 ore inizierà la fase esantematica, caratterizzata da quelle che impropriamente alcuni chiamano “bolle da scarlattina”, cioè un’eruzione cutanea (l’esantema appunto) di colore scarlatto che dà il nome alla malattia.
Le macchie della scarlattina sono molto caratteristiche: i puntini rossi sono piccoli, fitti e molto ravvicinati, un po’ sollevati tanto da dare alla pelle la consistenza di carta vetrata. Generalmente la scarlattina non dà prurito, inizia a livello inguinale e ascellare per poi ricoprire rapidamente – in circa 24 ore – tutto il tronco, gli arti e il viso.
Sul viso si possono notare due caratteristiche tipiche della malattia. La prima è la cosiddetta maschera scarlattinosa o di Filatow, che fa arrossare molto le guance ma che “risparmia” le aree del naso e della bocca, pallide per contrasto. La seconda invece riguarda la comparsa di segni della scarlattina sulla lingua, che all’inizio presenta una patina biancastra, con le papille rilevate, per poi diventare “a fragola rossa”, con le papille in evidenza e di colorito rosso acceso.
Possiamo notare anche una caratteristica tipica della scarlattina sulle mani; queste infatti assumeranno una colorazione pallido-giallastra nel momento in cui si andrà a premere sulla zona del rash.
Dopo tre-quattro giorni il caratteristico esantema della scarlattina lascia il posto a una desquamazione (di solito prima sul volto, poi sul tronco e infine sugli arti) che può durare anche più di una settimana.
Quindi, ricapitolando, come capire se è scarlattina oppure no? I sintomi più comuni della malattia, in ordine di comparsa, sono:
- febbre (anche alta, 38-40°C), mal di gola e sintomi influenzali;
- eruzione cutanea a livello di inguine e ascelle;
- diffusione dell’esantema su tutto il corpo, fatta eccezione per le aree attorno al naso e alla bocca;
- assenza di prurito;
- lingua con una patina bianca seguita da lingua a fragola rossa;
- desquamazione in seguito al rash cutaneo.
E la scarlattina senza febbre, esiste? Sì, una forma attenuata di scarlattina, con sintomi più lievi e sfumati, spesso senza febbre, esiste e viene chiamata scarlattinetta. Scopriamo ora dopo quanto tempo compaiono i sintomi della scarlattina.
Incubazione e contagio della scarlattina nei bambini
L’incubazione della scarlattina, cioè il tempo che separa l’esposizione al batterio dalla comparsa dei primi sintomi, è variabile, ma va solitamente da due a cinque giorni.
Per quel che riguarda il contagio della scarlattina, abbiamo già detto che la malattia si trasmette per lo più per contatto diretto, cioè attraverso il passaggio di goccioline di saliva da un soggetto all’altro. Dobbiamo però ricordare che è possibile ammalarsi anche per contagio indiretto, cioè attraverso oggetti contaminati (giocattoli, posate, bicchieri…) dalle secrezioni infette. Lo streptococco è infatti in grado di sopravvivere a lungo nell’ambiente. I luoghi in cui è più facile che si verifichi il contagio da scarlattina sono quindi asili, scuole, palestre…
Ma nel soggetto infetto, fino a quando la scarlattina è contagiosa? Se non viene avviata una terapia antibiotica, il rischio di trasmettere la scarlattina si prolunga per tutta la durata dell’infezione, quindi fino a due-tre settimane. Con un’adeguata terapia, invece, si azzera dopo 48 ore.
Come si cura la scarlattina nei bambini?
Senza un’adeguata terapia, quanto dura la scarlattina? Può durare diverse settimane, durante le quali il bambino, come abbiamo detto, continua ad essere contagioso se non è trattato con antibiotico. Pur essendo una patologia quasi mai pericolosa, se non adeguatamente trattata la scarlattina può comportare conseguenze a lungo termine legate all’infezione da SBEGA e il rischio di danni ai reni o al cuore. Per questo è importante, al primo sospetto, far visitare il bambino al pediatra, che prescriverà la cura antibiotica.
Per accertare l’infezione, in caso di sintomi sfumati o altri dubbi, può essere eseguito un tampone della gola con esame colturale, che permetterà l’isolamento del batterio responsabile. Da diversi anni sono inoltre disponibili dei tamponi rapidi, che possono essere eseguiti direttamente nello studio del pediatra e che danno il risultato in pochissimo tempo, permettendo di iniziare tempestivamente la terapia. L’amoxicillina è la molecola da preferire in quanto, ad oggi, non vi è evidenza di ceppi resistenti a questo antibiotico. Questa terapia va iniziata il prima possibile e il trattamento va proseguito per 10 giorni, al fine di prevenire le rare complicanze di cui abbiamo parlato. Già dopo 24-48 ore dall’avvio della terapia antibiotica il bambino non è più contagioso e, se sta bene, può tornare a frequentare la comunità.
Esiste un vaccino per la scarlattina?
O in ogni caso è possibile prevenire questa malattia? Non esiste alcuna evidenza a supporto del trattamento di un soggetto asintomatico per prevenire la malattia. Purtroppo, al momento non esiste un vaccino per la scarlattina, tuttavia forse non tutti sanno che la varicella favorisce l’infezione da scarlattina e che le due infezioni possono coesistere allo stesso momento; quindi, vaccinare i nostri bimbi per la varicella può proteggerli in parte anche dalla scarlattina.
La scarlattina, inoltre, non dà immunità, quindi ci si può ammalare più volte, anche se si tratta di un’evenienza piuttosto rara.
E se si contrae la scarlattina in gravidanza? L’infezione non è pericolosa né per la mamma in attesa né per il feto, e l’antibiotico utilizzato (amoxicillina) può essere tranquillamente assunto durante la gestazione. Tuttavia, se la malattia viene contratta alla fine della gravidanza, sebbene sia raro che essa venga trasmessa al bambino durante il parto, andrà valutata una terapia antibiotica anche per il neonato.

Pediatra, nel 2024 ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Immunologia, Medicina Molecolare e Biotecnologie Applicate presso l’Università di Roma Tor Vergata. Attualmente lavora come Clinical Research Fellow presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove svolge attività clinica presso il Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico e attività di ricerca presso i laboratori dell’Unità di Terapia Cellulare e Genica delle Malattie Ematologiche.
- Elena Bozzola, Scarlattina: incubazione, trasmissione e sintomi, «sip.it», 2020.
- Michael E Pichichero, Complications of streptococcal tonsillopharyngitis, «UpToDate», aprile 2023.
- National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Division of Bacterial Diseases, Scarlet Fever: All You Need to Know, «cdc.gov», ottobre 2022.