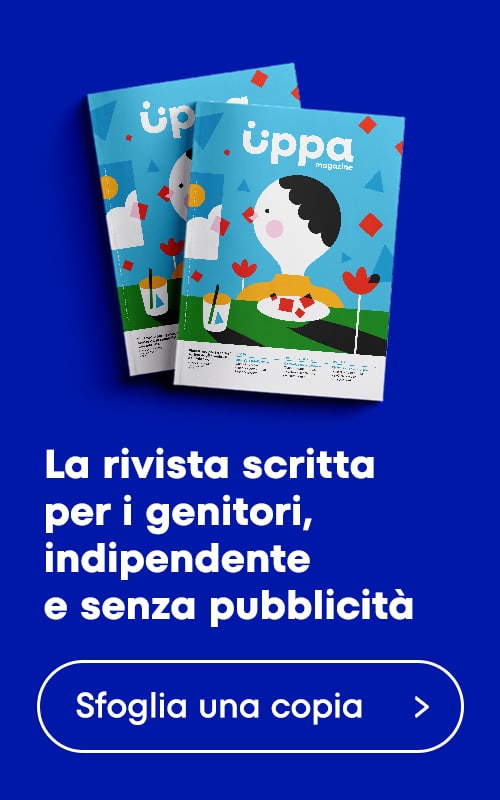Trisomia 21: cos’è la Sindrome di Down
Capire cos’è la Trisomia 21 significa conoscere le paure, i dubbi e le decisioni importanti che questa diagnosi comporta per ogni famiglia. Dalle cause ai fattori di rischio, dai sintomi alla diagnosi, fino alle prospettive di crescita e di vita del bambino con sindrome di Down, ecco un approfondimento accurato sul tema

Mina è seduta in sala d’attesa. È arrivato il giorno del test: il vociare del corridoio si confonde con il rumore dei suoi pensieri… «E se fosse così anche per noi, come è stato per mia sorella?», dice a Luca, il suo compagno. «Non aveva nemmeno 30 anni quando ha ricevuto la diagnosi di sindrome di Down per il suo bambino. Io che ne ho di più, cosa dovrei aspettarmi? Leggo ovunque che l’età più avanzata è un fattore di rischio. E se non riuscissimo ad affrontare tutto?».
Sono domande che attraversano la mente di tanti futuri genitori. Paure, dubbi, l’incertezza di non sapere cosa riserverà loro il futuro per quanto riguarda l’esito di un esame da cui dipenderanno tante scelte. Ogni gravidanza porta con sé attese e speranze, ma anche la necessità di fare i conti con scenari complessi e con momenti più difficili, come nel caso di una sindrome di Down appena diagnosticata.
Questo articolo vuole accompagnare le famiglie, i futuri e i neo-genitori in un percorso di conoscenza della Trisomia 21, un passo alla volta, dalle basi genetiche alle prospettive di crescita e di vita del bambino, con uno sguardo realistico e non giudicante nei riguardi delle scelte personali di ogni nucleo familiare.
Cos’è la sindrome di Down
La sindrome di Down, o Trisomia 21, è una condizione di origine genetica causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più. Normalmente ogni cellula contiene 46 cromosomi, organizzati in 23 coppie. Nelle persone con sindrome di Down, invece, ci sono 47 cromosomi poiché sono presenti tre copie del cromosoma 21.
Esistono tre tipologie principali di Sindrome di Down :
- Trisomia 21 o libera (95% dei casi). Il cromosoma 21 è presente tre volte in tutte le cellule, il che è dovuto a un errore casuale durante la divisione cellulare dei gameti (cioè gli ovuli e gli spermatozoi), chiamato “non disgiunzione”. La conseguenza è un gamete con due copie del cromosoma 21, che unendosi a un gamete normale durante la fecondazione porta alla formazione di una cellula che avrà quindi tre cromosomi 21.
- Sindrome di Down da traslocazione (4% dei casi). Un cromosoma 21, o meglio una sua parte, ovvero il braccio lungo, si attacca a un altro cromosoma (spesso il 14, 15 o, più raramente, il 21). Quando non si ha né perdita di materiale genetico né aggiunta – come in questo caso – si parla di traslocazione bilanciata, e un genitore può esserne portatore, con la possibilità di trasmetterla. Sono stati osservati casi più rari di traslocazioni tra cromosomi differenti e di sindrome di Down dovuta a traslocazione in bambini nati da genitori non portatori.
- Mosaicismo (1-2% dei casi). Non tutte le cellule hanno tre cromosomi 21, alcune in numero variabile hanno un numero normale di cromosomi (46), ed è la prevalenza dell’uno o dell’altro tipo di cellule a fare la differenza nella forma più o meno lieve della sindrome. In questo caso l’anomalia cromosomica (la non disgiunzione) avviene dopo la fecondazione.
La sindrome di Down è ereditaria? Solo nel caso in cui uno dei due genitori sia portatore di traslocazione è possibile che la Trisomia 21 venga trasmessa al bambino. Non avviene nel 100% dei casi, tranne per chi è portatore di una traslocazione tra due cromosomi 21, nel qual caso la trasmissione coincide sempre con la manifestazione della sindrome di Down.
Cause della sindrome di Down
Cerchiamo ora di seguito di approfondire meglio le cause della sindrome di Down.
Quando si presenta e perché
La sindrome di Down si presenta quando, prima o dopo il concepimento, si verificano delle anomalie durante il meccanismo di separazione dei cromosomi. Il motivo non è legato a una causa particolare poiché è un evento spontaneo, tranne nei rari casi citati prima. Esiste un rischio legato all’età materna, ma alla luce degli studi e delle indagini sempre più approfondite, non è esclusa nessuna fascia di età ed esiste anche un fattore legato all’età paterna, del quale si parla poco, oltre a una multifattorialità. Questo chiarimento dal punto di vista genetico, e quindi più tecnico, non deve in alcun modo far nascere un senso di colpa nei genitori, perché non dipende da comportamenti o azioni dirette materne e paterne.
Fattori di rischio per la sindrome di Down
Il principale fattore di rischio per la sindrome di Down è legato all’età materna più o meno in questi rapporti:
- ± 25 anni: 1 su 1.250-1450
- ± 35 anni: 1 su 350-380
- ± 40 anni: 1 su 100
- ± 45 anni: 1 su 30-40
Nonostante non sia stata molto approfondita, esiste anche un’influenza, seppur inferiore (5-6%), dell’età paterna sulla possibilità di avere un bambino con sindrome di Down. [1] .
Ad ogni modo, circa l’80% dei nati con sindrome di Down riguarda gravidanze in donne di età inferiore ai 35 anni, poiché in questa fascia di età si concepiscono e nascono più bambini. [2]
Nella maggior parte dei casi è l’ovocita, quindi la cellula materna, a essere portatrice della non disgiunzione, ma negli anni e attraverso diversi studi si è visto che se l’età rappresenta un fattore di rischio (non una certezza), pesano anche altri fattori, biologici, ambientali e socio-economici, che possono fortemente incidere sull’età materna, aumentando il rischio di Trisomia 21:
- Fumo e consumo di prodotti a base di nicotina. Ha un impatto sulla struttura dei cromosomi, sulla loro stabilità e sulla regolazione ormonale.
- Consumo di alcolici. Riduce nel tempo l’assorbimento di vitamina B12 e di acido folico, di più nel caso di una mutazione del gene MTHFR, che regola il metabolismo dei folati. Queste vitamine sono essenziali per il neurosviluppo fetale e per la stabilità delle cellule e della struttura dei cromosomi.
- Traslocazione del cromosoma 21. Se la madre ne è portatrice, c’è il 10-15% di rischio in più di avere un bambino con sindrome di Down, se è di origine paterna il rischio è del 3%. È possibile osservarla attraverso l’esame del cariotipo materno o paterno.
- La nascita di un figlio con sindrome di Down in una gravidanza precedente aumenta il rischio di ricorrenza.
- Status socio-economico. Uno studio condotto in diversi stati americani ha osservato che la bassa scolarizzazione familiare e uno status economico precario possono incidere sul maggiore tasso di Trisomia 21. Probabilmente perché ciò comporta un accesso più complicato ai programmi sanitari di screening e una minore consapevolezza verso uno stile di vita più salutare. [3]
Si parla sempre più di multifattorialità, che può amplificare o meno il fattore di rischio età, e la direzione sia nella ricerca sia nell’assistenza pre-concezionale è volta ad approfondire di più questo discorso e a valutare, a parità di età materna, gli stili di vita e il profilo genetico, per un adeguato supporto diagnostico e clinico.
Sindrome di Down: sintomi e caratteristiche
Quali sono i segni fisici nei neonati con sindrome di Down e quali sono, in generale, le caratteristiche cognitive e comportamentali di un bambino con Trisomia 21? Durante la gravidanza, quali segnali possono essere rilevati e in che modo?
Segni fisici nei neonati con sindrome di Down
I neonati con sindrome di Down possono presentare dei segni fisici distintivi, ovvero:
- forma degli occhi a mandorla con piega cutanea;
- volto piatto;
- mani piccole con un’unica piega palmare;
- tono muscolare ridotto (ipotonia);
- strato cutaneo più spesso sulla nuca;
- orecchie e bocca più piccole;
- alluce più distanziato dalle altre dita del piede;
- lassità articolare, cioè le articolazioni hanno meno stabilità e tenuta e sono più mobili;
- macchie di Brushfield, ovvero macchie bianche sull’iride;
- durante la crescita, la statura resta generalmente medio-bassa.
Non tutti i bambini nati con sindrome di Down presentano le stesse complicanze mediche, ma nel 50% dei casi può presentarsi una patologia cardiaca congenita come i difetti del setto interventricolare, che nella maggioranza dei casi vengono trattati con successo, con una buona qualità di vita conseguente e un tasso di sopravvivenza molto alto.
Nel 60% dei casi, i bambini e gli adolescenti con sindrome di Down possono presentare, crescendo, disturbi oculari come la cataratta, il glaucoma, lo strabismo, ma attualmente la presa in cura specialistica è sempre più precoce e adeguata per prevenire le complicanze più gravi.
Le endocrinopatie, soprattutto disordini della tiroide e il diabete, possono presentarsi durante la crescita, per questo sin da piccoli è importante che i bambini siano seguiti attraverso follow-up periodici, al fine di ridurre nel tempo l’impatto delle comorbidità.
Nei bambini e nei giovani adulti con sindrome di Down si osserva, nel 5-6% dei casi, una certa predisposizione a patologie gastrointestinali, che possono essere di tipo congenito soprattutto (come atresia o ostruzione duodenale e morbo di Hirschsprung), di tipo autoimmune (celiachia) o legate alla motilità intestinale, come il reflusso gastroesofageo.
Rispetto alla popolazione generale, si presenta una maggiore frequenza di malattie autoimmuni e una maggiore esposizione alle infezioni gastrointestinali, respiratorie e alle orecchie.
Caratteristiche cognitive e comportamentali
Lo sviluppo cognitivo nei bambini con sindrome di Down è variabile: il deficit intellettivo può essere lieve, moderato o in alcuni casi più grave, in un quadro molto variabile legato anche alle caratteristiche genetiche della trisomia.
Si possono presentare disturbi del linguaggio, iperattività e difficoltà dell’attenzione, ma ad oggi, grazie anche a una diagnosi precoce e a programmi sempre più su misura, sia educativi che riabilitativi, molti bambini acquisiscono buone competenze linguistiche e mostrano continui progressi nell’apprendimento. Nelle forme più gravi possono essere presenti comportamenti tipici dei disordini del neurosviluppo, che richiedono un sostegno cognitivo-comportamentale altamente specialistico e in grado di migliorare notevolmente la qualità di vita nei ragazzi e adulti con sindrome di Down.
Anche le caratteristiche caratteriali e comportamentali sono variabili, dal momento che possono cambiare in relazione all’età e allo stato di salute generale del bambino, poi adulto. Il carattere affettuoso e la socialità possono alternarsi a momenti di rigidità e ostinazione (soprattutto durante la crescita), rabbia e scatti d’ira, depressione e ansia. L’ambiente familiare, oltre al sostegno medico-riabilitativo e alla possibilità di praticare attività che stimolino il benessere psicofisico, la curiosità, e le attività manuali, ha un ruolo determinante nell’influenzare positivamente questi aspetti.
Sindrome di Down in gravidanza: quali sintomi notare
Durante la gravidanza non esistono sintomi specifici nella madre che possano indicare la presenza della sindrome di Down nel feto. Solo i test genetici e le indagini più approfondite, se necessarie, possono confermare la diagnosi, la presenza di problemi congeniti fetali e consentire di pianificare, con l’adeguato supporto sia medico che emotivo, i passi e le scelte da fare.
Diagnosi della sindrome di Down
La diagnosi prenatale della sindrome di Down si avvale di test non invasivi, ovvero:
- Screening per la sindrome di Down, cioè un test combinato (ecografia e analisi del sangue materno) che si esegue tra l’11^ e la 13^ settimana di gestazione e include la translucenza nucale, cioè la misura dello spessore dell’accumulo di liquido a livello della nuca fetale, e la valutazione dell’osso nasale. A questa ecografia si aggiunge l’esame di due ormoni prodotti dalla placenta, ovvero il PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein-A), fondamentale per la crescita fetale e lo sviluppo, e il free beta-hCG (frazione libera della gonadotropina corionica umana), componente dell’ormone HCG.
I valori e i risultati ecografici, correlati all’età materna, hanno un’attendibilità del 90-95%, e trattandosi di un test di screening, non diagnostico, se il risultato è positivo indica un rischio elevato che va approfondito con un esame più complesso e invasivo. - Ecografia morfologica. Eseguita tra la 16^ e la 18^ settimana, può rilevare delle caratteristiche congenite legate alla sindrome di Down, ma non confermarla senza un test combinato o un test del DNA fetale a precedere. Con questo tipo di ecografia è possibile rilevare la presenza di cardiopatie congenite, la lunghezza inferiore alla media delle ossa del femore e dell’omero, l’arteria ombelicale unica e la conferma dello spessore a livello della nuca.
- Test del DNA fetale o NIPT. Test non invasivo molto affidabile, che analizza il DNA fetale libero nel sangue materno attraverso un prelievo ematico. Può essere eseguito a partire dalla 10^ settimana di gestazione in poi, per valutare il rischio di diverse trisomie, tra cui la sindrome di Down, per cui l’accuratezza sale quasi al 99%. In Italia non è gratuito, tranne in alcune regioni dove è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza (Emilia Romagna, Valle d’Aosta). Anche in questo caso si tratta di un test di screening che, se positivo, va dunque approfondito con esami invasivi.
I test prenatali invasivi sono invece la villocentesi e l’amniocentesi. La prima prevede un prelievo dei villi coriali (delle protuberanze presenti nella placenta), la seconda un campione di liquido amniotico, nel quale sono presenti le cellule fetali.
La diagnosi post-natale nei neonati si basa sull’osservazione delle caratteristiche cliniche, di sintomi legati a patologie congenite già diagnosticate in gravidanza, di sintomi nuovi, e rende necessaria una presa in cura multidisciplinare. Viene eseguito anche il test della conferma del cariotipo, per il numero dei cromosomi, e viene valutata la possibile coesistenza di altre patologie genetiche o congenite, non diagnosticabili nel periodo prenatale. Già nel periodo neonatale si inizia a predisporre non solo un percorso diagnostico, ma anche di cura e riabilitazione precoce per garantire una qualità di vita migliore possibile.
Incidenza della sindrome di Down nel mondo
A livello globale, la Sindrome di Down si verifica in un caso su 1.000-1.200 nati vivi. In Italia si verifica in un caso su 1.200 circa, mentre negli Stati Uniti d’America la media è di un nato su 700. «Ma la sindrome di Down è presente in tutte le etnie?». Spesso alcune condizioni genetiche hanno una maggior prevalenza in determinati gruppi etnici, tuttavia non è questo il caso. La sindrome di Down è infatti presente tra le diverse etnie senza alcuna distinzione. A variare, semmai, è la possibilità di accesso all’assistenza pre e post natale, che dipende dalle condizioni sociali ed economiche delle diverse aree geografiche. Dal momento che in molte aree rurali e, in generale, nei Paesi in via sviluppo manca un’assistenza sanitaria adeguata, non ci sono dati precisi sul numero di nati con sindrome di Down, spesso riconosciuta solo dopo la nascita e senza una vera e propria presa in carico del soggetto (il che comporta anche una minore aspettativa di vita).
Crescita e sviluppo delle persone con sindrome di Down
La crescita e lo sviluppo dei bambini con sindrome di Down dipendono molto dalla stimolazione precoce, dalla presenza di altre patologie, dal sostegno riabilitativo nel linguaggio e nelle abilità psicomotorie.
Molti bambini riescono oggi a raggiungere un’autonomia e dei traguardi che qualche decennio fa erano impensabili per quanto riguarda ad esempio la capacità nella gestione delle difficoltà quotidiane o di praticare degli sport.
L’aspettativa di vita media nelle persone con sindrome di Down è arrivata a 60 anni circa, con alcuni casi rari che hanno raggiunto gli 80 anni.
Nel percorso di crescita l’aspetto sociale e pedagogico riveste un ruolo essenziale. Quando si parla di sindrome di Down, la scuola rappresenta un tassello fondamentale, poiché attraverso programmi specifici e insegnanti specializzati garantisce la formazione e l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con Trisomia 21, migliora la loro capacità di apprendimento e le loro abilità logiche di base, permette sia a loro che alle loro famiglie di scoprire i punti di forza e le qualità da sfruttare al meglio.
Sono tante le storie di ragazze e ragazzi con Trisomia 21 che hanno affrontato il proprio percorso di studi con successo e grande determinazione, con lo sforzo congiunto delle famiglie e di strutture di riferimento che supportano e sostengono la loro crescita con diverse attività.
Convivere con la sindrome di Down oggi
Convivere con la sindrome di Down oggi significa affrontare delle sfide ma anche scoprire risorse preziose. I genitori dei ragazzi con Trisomia 21 cercano di favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei propri figli anche attraverso opportunità di inserimento lavorativo: un ambito in cui la nostra società deve ancora compiere passi avanti, superando pregiudizi e mancanza di accoglienza. Ma senz’altro l’inclusione e l’autonomia di questi ragazzi si costruisce anche nella quotidianità, attraverso tanti aspetti, piccoli e grandi, pratici ed emotivi, relazionali e di attività condivise in gruppo.
Le famiglie che dispongono di maggiori risorse e di un adeguato supporto, sia dal punto di vista socio-sanitario sia grazie alle associazioni territoriali, possono offrire ai propri figli delle opportunità in più, anche in un’ottica di futuro.È vero, il percorso non è uguale per tutti, ma il messaggio è univoco: la sindrome di Down non definisce una persona, è solo una parte della sua storia, che può essere scritta ancora in tanti modi.
[1] AA.VV. The Influence of Paternal Age on Down Syndrome The Journal of Urology, vol. 169, n. 6, giugno 2003, pp. 2275-2278
[2] CMDSS Causes and Statistics – What Causes Down Syndrome? cmdss.org
[3] AA.VV. The association of low socioeconomic status and the risk of having a child with Down syndrome: a report from the National Down Syndrome Project Genetics in Medicine, vol. 15, n. 9, settembre 2013, pp. 698-705
Bibliografia
-
Aktar F., Bokhari S.R.A., “Down Syndrome”, StatPearls, agosto 2023.
-
Bhaumik P., Bhattacharya M., Ghosh P., Ghosh S., Kumar Dey S., “Telomere length analysis in Down syndrome birth”, Mechanisms of Ageing and Development, 164, 2017, pp. 20-26.
-
Bunt C.W., Bunt S.K., “Care of Infants and Children With Down Syndrome: Role of the Family Physician”, American Family Physician, 2025.
-
Liu J., Wang S., Zhou S., et al., “Cost-effectiveness of different screening strategies for Down syndrome: a real-world analysis in 140,472 women”, Frontiers in Public Health, maggio 2025.
-
Rutter T.L., Hastings R.P., et al., “Psychological wellbeing in parents of children with Down syndrome: A systematic review and meta-analysis”, Clinical Psychology Review, vol. 110, giugno 2024.
-
Seaton S.E., Rankin J., Carbonello C.C., et al., “The Healthcare Needs of Children With Down Syndrome in the First Year of Life: An Analysis of the EUROlinkCAT Data Linkage Study”, Pediatric Perinatal Epidemiology, luglio 2025.
Immagine in apertura FatCamera / iStock